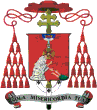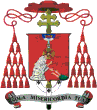Simposio «L’autorità del magistero in morale»
2 settembre 1980
Il tema sul quale mi è stato chiesto di riflettere è “la natura ed il fondamento dell’autorità del Magistero della Chiesa nell’ambito della legge naturale” e “il rapporto fra Magistero e coscienza dei fedeli”, più precisamente “la normatività del Magistero per la ricerca etica e per la coscienza morale”.
È facile vedere che il momento decisivo della presente riflessione è costituito dalla prima tematica (la natura ed il fondamento....), essendo la soluzione degli altri due una conseguenza.
Si noti ancora ed infine che la riflessione è rigorosamente circoscritta ad un ambito particolare dell’esercizio del Magistero, quello della legge naturale.
LO “STATUS QUAESTIONIS” GENERALE
È un fatto che il Magistero ha insegnato, impegnandovi la sua autorità propria e specifica, norme morali giudicate e presentate dal medesimo come norme di legge naturale. La descrizione concettualmente più rigorosa di questo fatto, mi sembra, è offerta nell’Enciclica Humanae Vitae 4,2.
Da questo testo risultano le seguenti caratteristiche di questo Magistero:
(a) si tratta di un insegnamento dato in forza dell’autorità di Cristo stesso e dunque rientrante nell’ambito proprio e specifico del Magistero;
(b) il suo oggetto non è propriamente la norma morale rivelata, ma quella razionalmente giustificabile (non solius legis evangelicae, sed etiam naturalis, ibid.).
L’esistenza di un Magistero così caratterizzato pone indubbiamente problemi teologici difficili, oggi largamente dibattuti in teologia morale. A me sembra che le radici ultime di questa problematica siano sostanzialmente due. Le espongo in forma di domanda:
1. Come è possibile un Magistero vero e proprio in un ambito che, per definizione, è distinto dal Dato rivelato, dal momento che, come ha insegnato Vaticano I (DS 3070) e Vaticano II (LG 25,1), oggetto proprio e specifico del Magistero è il medesimo Dato?
2. Come è possibile l’esistenza di un potere vincolante nell’ambito delle scelte morali, che sono ultimamente mediate dal giudizio autonomo della coscienza?
La risposta a queste due domande fondamentali costituirà rispettivamente la prima e la seconda parte del presente studio. Ad esse ne seguirà una terza riguardante la ricerca etica.
1. RIVELAZIONE - LEGGE NATURALE - MAGISTERO
Storicamente il primo problema ha potuto sorgere, nei termini attuali, a causa di quella profonda presa di coscienza della distinzione della ragione dalla fede, che costituisce uno dei tratti caratteristici dall’epoca moderna. Presa di coscienza che ha avuto molteplici manifestazioni storiche che, per il nostro scopo, non è il caso di richiamare. È solo necessario qualche essenziale riferimento per cogliere la portata di questa prima problematica, che delle due è decisamente la più importante.
1,1 (Lo “status quaestionis”). Il rifiuto da parte della ragione, in quanto facoltà che istituisce nome morali, di una autorità religiosa, che formalmente la preceda e la giudichi nei suoi risultati, è un dato che fa parte essenziale della cultura moderna. Quali sono le radici di questo rifiuto?
È, innanzitutto, intervenuta una nuova definizione di ragione, espressione di un modo nuovo con cui l’uomo comprende se stesso. La ragione non è più concepita come la capacità, nell’uomo, di una verità che la trascende ed alla cui accoglienza essa si dispone, ma è concepita come funzione di una verità che essa costituisce {mediante il rapporto strumentale con le cose osservabili ed utilizzabili}. All’origine di questa trasformazione del concetto di ragione sta l’ideale di un orizzonte razionale autonomamente fondato, privo di ogni presupposto, caratterizzato da una certezza assoluta: ideale programmaticamente formulato da Cartesio.
Conseguenza di capitale importanza è la trasformazione del concetto di evidenza, che regge l’ideale del sapere; dal concetto secondo cui esiste una differenza insopprimibile fra la verità che fonda la evidenza e la determinazione concettuale ed empirica che la specifica, si passa ad una nozione univoca di evidenza, in cui è la ragione a costituire e, dunque, a misurare esaustivamente l’evidenza da essa istituita.
In tal modo, è spezzato il vincolo fra il rapporto dell’uomo alla verità, data anteriormente alla riflessione critica e da questa mai totalmente recuperabile, e l’accertamento critico delle condizioni oggettive della manifestazione della verità. Una delle conseguenze più importanti, in sé e dal nostro punto di vista, è la completa astrazione della riflessione, anche etica, da una qualsiasi tradizione ed esperienza in cui sia già dato un sapere etico: di fatto — in Occidente, l’esperienza e la tradizione ecclesiale. Si rompe quella “circulatio” fra questa e la ragione (modello, e.g., della Somma Teologica tomista, secondo il concetto di ragione in esso operante). Al contrario, si istituisce e si mette in atto quel concetto di “etica razionale” o “etica naturale” (in concomitanza e connessione con quello di “religione naturale”) che trova la sua completa autogiustificazione nella ragione, intesa come sopra. E poiché ciò non comporta necessariamente, almeno agli inizi e comunque per il teologo, l’eliminazione dei contenuti della tradizione etica cristiana predicata dalla Chiesa, essi vengono collocati in uno spazio ulteriore ed esteriore alla ragione, resa possibile da un organo speciale, la Fede, senza un rapporto organico colla ragione. Significativa, al riguardo, la contrapposizione kantiana fra etica ecclesiastica come etica “statutaria” ed etica razionale cone etica “autonoma”.
Le figure della giustapposizione variano (e.g. etica della fede=etica dei consigli ev./etica razionale=etica dei comandamenti; etica della fede come pura conferma estrinseca di un sapere etico razionale....), ma alla base sta sempre lo stesso assunto: la negazione di un rapporto intrinseco fra ragione e fede, radicato nel rapporto originario dell’uomo alla Verità. Negazione che condizionerà tutto il dibattito moderno sul Cristianesimo, fin dagli inizi (Cartesio-Pascal).
Da queste schematiche ed essenziali riflessioni dovrebbe già risultare, con sufficiente chiarezza, la posta in gioco di questa prima problematica che dobbiamo affrontare. Essa chiama ultimamente in causa il problema centrale della cultura moderna, il problema del rapporto fede-ragione, di cui l’attuale discussione teologica sulla natura e fondamenta dell’autorità del Magistero nell’ambito della morale razionale non è che una espressione, fra le più inequivocabili e decisive, Ed, infatti, l’autorità del Magistero è la mediazione ultimamente decisiva dell’autorità del Dato rivelato.
Se la radicazione storica, da noi ipotizzata e schematicamente richiamata, è corretta, essa offre il contesto teoretico entro cui il problema deve essere risolto e, coerentemente, la prospettiva di soluzione.
Si tratta, in sostanza, di ricuperare l’unità profonda di fede e ragione, nelle loro rispettive caratterizzazioni, dimostrando come sia un puro pregiudizio il pensare che la fede si rapporti in modo solo estrinseco alla conoscenza razionale. Entro questo contesto teoretico, la soluzione dovrà essere cercata e nella più profonda comprensione che il Vaticano II ha avuto del Magistero e nell’originario rapporto che la fede ha con la ragione, anche pratica, dell’uomo. Perché, in sostanza, una fondazione e una definizione teologica dell’autorità del Magistero nell’ambito dell’etica razionale, diviene impossibile se non si desse quel rapporto.
Le riflessioni seguenti intendono muoversi nella direzione di questa prospettiva, colla sola presunzione di far cogliere le implicazioni teologiche e di fede di questa problematica, e di offrire una qualche occasione di dibattito ai partecipanti al Simposio.
1,2 (Una risposta al problema). Occorre, dunque, superare la configurazione estrinsecista del rapporto fede-ragione, la quale, e teoreticamente e storicamente, ha avuto come esito o la riduzione razionalistica del creduto al razionale o l’espulsione fideista della fede dall’area della ragione. Ambedue gli esiti si ritrovano, puntualmente, anche nell’ambito della nostra problematica: o l’identificazione pura e semplice dei “praecepta fidei” con i “praecepta rationis” (ed in questo caso il Magistero è insignificante ed inutile) o la separazione dell’etica della fede dalla etica della ragione (ed in questo caso il Magistero “in lege naturali” è contrario alla dignità dell’uomo ed all’autonomia della sua ragione pratica).
Il superamento di queste posizioni può essere compiuto solo a due condizioni. Da una parte mostrando la connessione fra fede e ragione e, dall’altra, mediante una visione completa del Magistero, la qua le implichi anche l’essenziale dovere di questo, di concretizzare l’esigenza morale della Grazia e di precisarla per ogni epoca. E questi, pertanto, saranno i due momenti essenziali della soluzione che mi permetto ora di presentare.
1,2,1 - È necessario partire dalla costatazione che la fede cristiana ha una concezione propria e specifica della verità, proprietà e specificità di cui la teologia post-tridentina non ha sempre avuto una sufficiente consapevolezza.
In senso propriamente cristiano, la verità è la rivelazione di Dio, definitivamente accaduta nella vita-morte-risurrezione di Gesù successivamente interiorizzata nel cuore dei credenti dallo Spirito loro donato, per renderli partecipi della stessa vita del figlio di Dio.
L’elemento centrale di questa concezione cristiana della verità è l’identificazione fra ossa e Gesù il Cristo. Ne consegue che essa costituisce il criterio valutativo di ogni sapere della fede, di ogni teologia. La verifica, cioè, della compatibilità cristologica di ogni discorso sulla verità è il modo con cui esso si dimostra come sapere in cui la Rivelazione, e non altro da Essa, è principio epistemologicamente e metodologicamente operante della ragione teologica.
Esprimerei questa identificazione nel modo seguente. È l’identificazione in Gesù fra la sua intenzione di rappresentare, mediare l’assoluto affermarsi della Verità di Dio e la forma della donazione incondizionata ed illimitata che giunge, come necessità dell’amore, fino alla morte in Croce. E si notino bene le due grandezze che fanno la identità. È la Verità di Dio, il suo Mistero inaccessibile, che Gesù svela completamente e, pertanto, insuperabilmente, una volta per sempre; è la donazione illimitata ed incondizionata, fino alla morte per la salvezza dell’uomo, che costituisce l’evento della Rivelazione di Dio. La assoluta singolarità di Gesù sta in questa identità, per cui Egli è e colui che rivela e colui che è rivelato: è la Verità.
Data la natura della Verità, come è pensata cristianamente, Essa si mostra inscindibilmente connessa con il “Comandamento” che, pertanto, riceve da questa connessione la sua specificità propriamente cristiana (come la definizione di verità). Infatti, se la Verità è la donazione illimitata ed incondizionata di Gesù, se è, cioè, la vita stessa di Gesù donata fino alla morte, allora questa stessa donazione costituisce il senso dell’esistenza, la misura della propria ragione d’essere (cfr. Gv,13,34-35). Un senso, pertanto, che si rapporta alla libertà dell’uomo essendo costituito dall’amore. In quanto e poiché Gesù è la Verità, Egli è il Comandamento.
Dicevo poc’anzi che questa identità di Gesù con la Verità-Comandamento costituisce il principio originario ed originante di ogni sapere teologico cioè di ogni sapere della fede. Ma in che modo l’identità suddetta può divenire epistemologicamente operante e metodologicamente efficace per l’edificazione di un sapere che voglia conoscere la verità della fede e del suo comandamento? Si tratta di elaborare un modello di ragione che, ispirata dalla fede, sia in grado di conoscere la verità della medesima.
Se non vado errato, dalla Tradizione ecclesiale emergono due orientamenti fondamentali. Da una parte, si ha il rifiuto di una contrapposizione fra ragione, e dunque verità della ragione, e fede, e dunque verità della fede. Dall’altra, si ha l’affermazione di una soprannaturale elevazione della ragione e della sua verità nella e mediante la fede, elevazione che implica e una guarigione della ragione ed una sua intrinseca trasformazione.
Sempre se non vado errato, dentro a questo duplice orientamento e nutrita dalla esperienza di fede, la riflessione dei credenti ha elaborato un sapere metafisico che, storicamente nato nel seno della Chiesa, si è a buon diritto esibito come sapere razionalmente giustificato e giustificabile. In altre parole, la fede ha rivelato la ragione a se stessa, consentendole di essere se stessa (l’ha salvata), nel suo originario rapporto colla verità, colla totalità, coll’essere. Per cui avanzerei questa ipotesi interpretativa di tutto il processo culturale occidentale moderno: una volta salvata nel suo originario rapporto colla verità, dalla fede, la ragione, ponendosi fuori o contro la fede, ha finito col riperdere se stessa. Ritornerò più avanti su questo punto: solo cogliendo nella fede la Verità che è Cristo, la ragione è pienamente se stessa.
Quel sapere metafisico di cui parlavo poc’anzi, trova il suo centro nel principio della creazione o della “differenza metafisica” (in un senso molto più ricco di quello heideggeriano).
La “differenza metafisica” esprime la verità della relazione originaria dell’Essere, in se stesso sussistente, con l’esistente, con l’uomo. Una relazione che è posizione in essere di un altro, da parte di Dio, a Dio costitutivamente relazionato. Una relazione che nasce da un atto di assoluta libertà, perché frutto della gratuità dell’amore. E la divaricazione essenziale dal pensiero heideggeriano, come da ogni pensiero che ignori la creazione, sta precisamente in questo. Presso Heidegger, l’evento dell’essere si riduce a qualcosa di impersonale: il puro “es gibt” dell’essere, la pura donazione anonima, che fa della persona umana il luogo impersonale di un anonimo avvenimento. Nella luce della differenza metafisica, pensata sulla base del principio della creazione, la misteriosità dell’esserci dell’uomo è ultimamente dovuta alla sua inspiegabilità con ragioni necessitanti, perché la sua ragion d’essere è la pura gratuità dell’amore creativo.
Da ciò consegue una ulteriore riflessione, di grande importanza per la nostra questione. Il rapporto originario dell’uomo con la verità è sinteticamente dato ed istituito con il rapporto originario dell’uomo con il bene. O, che è lo stesso, l’originaria esperienza che l’uomo vive nel suo rapporto con l’essere è sinteticamente all’indicativo ed all’imperativo. Infatti, la domanda dell’uomo, che nasce dal suo stupore originario, “perché si dà l’essere di qualcosa e non piuttosto il nulla?”, è domanda e sulla verità dell’essere dell’ente e sul senso dell’essere dell’ente. Per questa connessione di verità e senso, la conoscenza della verità presuppone ed implica la decisione libera di andare oltre l’essere dell’ente e la decisione libera, a sua volta, è obiettivamente insinuata e richiesta dalla verità che si dà a conoscere. Al riguardo le riflessioni agostiniane sono un guadagno definitivamente acquisito dal pensiero cristiano.
In questa prospettiva, appare, mi sembra, la povertà del concetto di ragione, che sta alla base della contrapposizione di essa alla fede e del loro rapporto estrinseco.
La riduzione della razionalità alla pura evidenza, del pensiero al pensiero calcolante, del rapporto originario dell’uomo alla verità al rapporto strumentale con le cose osservabili ed utilizzabili, dimentica che la verità, cui l’uomo è intenzionato, è la verità dell’essere il cui senso non si impone per necessitante evidenza, ma fa appello alla libertà dell’uomo. La differenza metafisica, istituita dalla creazione, non può essere colmata da nessuna evidenza incontrovertibile o deduzione corrispondente (contro ogni monismo) né si lascia pensare opponendo radicalmente i differenti (contro ogni dualismo); né, di conseguenza, i due modelli di razionalità corrispondenti, mostrano la verità dell’uomo. In quanto la differenza è costituita dalla libera gratuità dell’atto creativo, la ragione deve essere pensata come accoglienza, con-senso ad una verità destinata alla libertà dell’uomo in cerca della sua salvezza.
Se non sbaglio, mi sembra questo il modello di razionalità che può essere assunto dalla fede nel suo sforzo di capire la sua propria Verità.
Infatti, la Verità, come già ho detto, nel senso cristiano è Gesù Cristo, è la sua donazione illimitata ed incondizionata, è la sue vita donata fino alla morte per amore. E, pertanto, solo una ragione che sappia esprimersi, esercitarsi come funzione di una verità che si mostra nella gratuità della donazione, può sapere e capire la Verità del la fede. Ma per questo, mi sembra di dover dire che la ragione teologica attuale deve guarire dal suo antropocentrismo, dentro il quale la Verità rischia continuamente di essere “dedotta” dalla struttura trascendentale dello spirito umano. Infatti, se questa deduzione è fatta a partire dalla struttura stessa, essa riduce la storia della Rivelazione ad oggettivazione categoriale di una presupposta condizione trascendentale; oppure, se parte dal Fatto, essa è costretta a ridursi ad argomentazione di convenienza apologetica.
1,2,2 - Nel contesto di questa riconciliazione fra ragione e fede, appare la necessità per il Magistero di intervenire anche nell’ambito dell’etica razionalmente elaborata dal credente, e la natura e il significato di questo intervento.
È fuori dai compiti del mio intervento elaborare una riflessione completa sul concetto di etica razionale e di norma morale razionale, così come del Magistero. Mi devo accontentare di alcuni richiami schematici ed essenziali, che funzionano come presupposti alla risposta al nostro problema.
Penso che si possa presumere un consenso sulla definizione di etica razionale come sapere che ha per oggetto il valore incondizionato della persona umana e di norma morale razionale come criterio veritativo-valutativo delle scelte che promuovono/negano questo valore. La ragione etica è, pertanto, la ragione che sa e promuove la dignità assoluta di ogni persona umana, la sua verità propria e specifica.
Penso pure che si possa presumere un consenso sul fatto che non si debba separare il ministero apostolico nella Chiesa da ciò che si può chiamare la sua materia, il suo contenuto. La ragione d’essere del ministero nella Chiesa, e dunque il suo fondamento, è di trasmettere la Verità di Cristo, anzi la Verità che è Cristo, che è la sua donazione illimitata ed incondizionata. Testimonianza autentica, perché istituita da Cristo ed assistita dallo Spirito; i successori degli apostoli sono i custodi del senso ultimo della vita, i custodi dell’intera misura dell’uomo. Data, infatti, la natura della Verità cristiana, il servizio del ministero apostolico non può non implicare necessariamente il servizio alla vita che la Verità suscita. In quanto la verità testimoniata è identicamente, come si diceva, dono del “comandamento nuovo”, la testimonianza apostolica ha per oggetto anche la nostra vita in questo mondo. È precisamente questa vita che, mediante la parola di salvezza, si apre alla Presenza di Dio, rivelatosi in Cristo, perché Egli diventi tutto in tutti. In una parola: la testimonianza alla Verità sarebbe sostanzialmente lacunosa se non implicasse anche l’indicazione del modo con cui questa Verità deve essere fatta.
Fatto questo duplice presupposto, siamo così arrivati al momento decisivo della nostra riflessione. La necessità che il Magistero si estenda anche nell’ambito dell’etica razionale si mostra da molteplici punti di vista fra loro connessi.
A) In quanto testimonianza alla Verità che è Cristo, il ministero apostolico riconduce la ragione etica alla sua verità, al suo rapporto originario con la verità, che solo una visione non completa ha potuto pensare in termini di dominio, di costituzione del vero da parte della ragione. È il servizio reso alla verità della ragione nel sua interezza, della ragione etica in particolare. Proponendo norme morali razionali, in forza dell’autorità ricevuta da Cristo, il Magistero svolge quel servizio di salvezza anche per la ragione umana, che gli compete, consistente in due aspetti.
Da una parte, esso guarisce la ragione etica dalla permanente tentazione di misurare la grandezza ed il valore dell’uomo non secondo l’incommensurabile misura istituita dalla differenza metafisica. Dall’altra, esso mostra le incidenze, nell’ambito della promozione dell’uomo, del comandamento nuovo, che è la donazione illimitata ed incondizionata di Cristo. Incidenze e conseguenze che la ragione del credente può cogliere proprio in quanto ragione, restituita pienamente dalla fede al suo rapporto originario con la verità.
B) In questo modo, due luoghi ricorrenti nel Magistero morale
che sembrano contraddirsi, sono profondamente in armonia. Quando il Magistero insegna norme morali da esso giudicate razionali, e si richiama all’autorità di Cristo e nello stesso tempo si richiama alla ragione etica dell’uomo che rettamente si eserciti (recta ratio). Che sembrano due richiami contradittori. In realtà c’è una armonia in questo.
Proprio perché il Magistero è il testimone autentico della Verità di Cristo, esso è sicuro che le sue indicazioni per la promozione dell’umano come tale, rispondono pienamente alla intera verità di questa e, dunque, alle esigenze della ragione. La sua certezza non gli viene da altro che dall’essere ciò che Cristo ha voluto che fosse; pertanto, solo esso può possedere una simile autorità in campo morale.
Reciprocamente proprio perché la ragione si definisce, nel suo originario rapporto con la verità ed il bene, come accoglienza e consenso, e non come misura della verità e del bene, essa si apre, dal suo interno, a ricevere il dono di una verità che le è destinata come sua propria.
La cosa può essere meglio spiegata in analogia colla ragione teoretica. Questa di fatto, non ha percepito nella sua interezza la verità della differenza metafisica, il principio della creazione, Alla ragione questa verità è stata donata dalla fede. Ma questo dono non si è aggiunto, giustapposto alla ragione considerata nel suo rapporto originario con l’essere ed alle verità generate da questo rapporto. Al contrario. Questo dono ha restituito la ragione a se stessa; nel senso che in questo dono ha trovato risposta alla sua esigenza più profonda, alla domanda che la costituisce come tale, la comanda sull’essere.
Secondo Rom. 1,18-25, l’avere la ragione perso il suo rapporto originario con la verità, non è dovuto ad una incapacità strutturale di dimorare in esso, ma ad una libera decisione di uscirne. Decisione che consiste nel fare di se stessa la misura ultima della verità (=idolatria).
L’annuncio del Vangelo, della Verità che è Cristo, nello stesso momento in cui rivela all’uomo la sua destinazione alla comunione intra-trinitaria, riporta la ragione alla sua verità propria e naturale.
Analogamente vanno le cose per quanto riguarda la ragione pratica. Il dono del “comandamento nuovo” (amatevi come Io vi ho amati), il cui annuncio autentico compete al Magistero, non si giustappone alla ragione umana considerata nel suo rapporto originario con il bene e alle norme da esso generate. Al contrario. Questo dono restituisce la ragione a se stessa, nel senso che la ispira interiormente, la guida perché essa, di una parte, non elabori norme morali non coerenti con il Comandamento nuovo e, dall’altra, traduca nell’ambito umano, nel modo a questo conforme, la misura della donazione di Cristo [nota: È quanto S. Tommaso, nel solco della tradizione, esprime col solito rigore, là dove pensa il rapporto fra carità e virtù morali. “Non invenitur principium aliquorum operum in aliqua re, quin inveniatur in ea quae sunt necessaria ad huiusmodi opera perficienda... Manifestum est autem quod caritas, in quantum ordinat hominem ad finem ultimum, est principium (attraverso le virtù morali) omnium bonorum operum quae in finem ultimum ordinari possunt” (1,2,65,3c). Ed ancora: “oportet ad hoc quod homo bene operetur in his quae sunt ad finem, quod non solum habeat virtutem qua bene se habeat circa finem, sed etiam virtutes quibus bene se habeat circa ea quae sunt ad finem” (ibid.ad 1um)].
È per questa connessione intima, intrinseca, fra il Comandamento nuovo e l’etica razionale, che il Magistero, insegnando la fede “da credere e da applicare nella pratica della vita” (LG 25,1), verrebbe meno al suo compito se non insegnasse anche le coerenti conseguenze di essa riguardanti gli ambiti dell’umano (cfr. di conseguenza quanto è detto nel decreto Christus Dominus 12).
C) Scopriamo così le radici ultime delle difficoltà incontrate da parte di alcuni teologi cattolici contemporanei nel giustificare ed ammettere una vera e propria autorità del Magistero nell’ambito dell’etica razionale. Esse,mi sembra, affondano tutte nel terreno di un pregiudizio: la reciproca esclusione di fede (dunque anche del Magistero che appartiene alla fede) e ragione, in forza della quale la fede non è razionale e la ragione non è credente e, pertanto, i “praecepta fidei’’ non sono razionali ed i “praecepta rationis” non possono rimandare ad una autorità di fede. È, insomma, la difficoltà di pensare un rapporto organico fra ragione e fede.
Una volta intervenuta la decisione della fede, si pensa che la ragione etica proceda autonomamente, nella elaborazione delle sue norme. La Verità rivelata del Comandamento nuovo diventa, come tale, epistemologicamente inoperante nell’edificazione, da parte del credente, di un’etica che ha per oggetto gli ambiti della creazione come tale. Per essere più precisi. Mentre secondo la grande Tradizione del pensiero cristiano, l’etica razionale è l’etica assunta dalla fede, che le garantisce autonomia formale e connessione con la verità totale, ed in questa connessione si fonda la necessità dell’intervento del Magistero, per alcuni teologi non sufficientemente critici, l’etica razionale è l’etica separata, emancipata, indipendente rispetto alla fede, ed in questa separazione, un Magistero è ingiustificabile.
Solo in un modo di rapportare fede e ragione, etica della fede ed etica della ragione, ed in ultima analisi Cristo e creazione, che superi il pregiudizio della reciproca esclusione, il Magistero è giustificabile ed anzi necessariamente affermabile. “È in Cristo che la Chiesa è esperta in umanità” (Giovanni Paolo II, discorso a Salvador de Bahia del 6/7/80,4): questa è la definizione perfetta del Magistero “in lege naturali”.
In conclusione: l’affermazione dell’autorità del Magistero “in lege naturali” è un corollario necessariamente derivante dalla concezione cattolica del rapporto fede-ragione, etica della fede-etica della ragione, ultimamente, Cristo-creazione.
2. MAGISTERO E GIUDIZIO DELLA COSCIENZA MORALE.
Il secondo nodo problematico mi sembra di minor difficoltà, alla luce di quanto già si è detto. Il problema sta in questo: come è possibile parlare di autorità vincolante la coscienza morale del singolo, dal momento che questa costituisce l’imprescindibile mediazione soggettiva fra la norma morale e la scelta concreta del soggetto agente? Ma, anche ora, è necessario precisare lo status quaestionis.
Non si dà identità fra ragione pratica dell’uomo e coscienza morale. La prima connota la facoltà del giudizio morale universale, la seconda l’atto mediante il quale la persona, nella sua irripetibile singolarità, giudica che cosa, hic et nunc, deve/non deve fare. L’identificazione delle due significa semplicemente la distruzione dell’etica, nel senso di un formalismo essenzialista o nel senso di un situazionismo in cui il valore è lo stesso fatto. Da ciò consegue che la ragione è l’organo che rapporta l’uomo alla Verità morale, mentre la coscienza è la fonte dell’imputabilità morale. Da ciò ancora consegue la necessaria distinzione (di S. Tommaso) fra il “recte agere” ed il “peccatum non incurrere” o, che è lo stesso, fra ciò che è oggettivamente male e ciò che è soggettivamente colpevole.
Ciò premesso, se non sbaglio, mi sembra di poter dire che il rapporto fra Magistero e coscienza morale non è immediato, ma mediato. Mediato dalla e nella conoscenza della Verità e norma morale. In altre parole, il Magistero non insegna ciò che il singolo, hic et nunc, nella sua irripetibile singolarità, deve fare (solus coram Deo: GS 16).Ma, esso insegnando la Verità morale, anche razionale, costituisce un punto di riferimento obbligato, in ragione del suo essere ciò che è nei confronti della Verità, e in ragione della struttura della Verità di cui è testimone, come già si è visto.
I termini esatti del problema mi sembrano pertanto i seguenti: in che cosa consiste questo riferimento della coscienza al Magistero, testimone autentico della Verità?
2,1. Uno degli elementi della specifica originalità con cui il Cristianesimo pensa la Verità è il carattere di interiorità. La Verità-Comandamento, che è Gesù il Cristo nella sua donazione illimitata ed incondizionata, deve essere posseduta dall’uomo sotto l’azione dello Spirito. L’uomo deve farla sua; la Verità-Comandamento deve farla risiedere in se stesso. Come si sa, nella Tradizione latina furono soprattutto Agostino e Gregorio Magno ad approfondire questo dato e Tommaso d’Aquino, sulla scia di Agostino, pone nella interiorizzazione dei Comandamento per opera dello Spirito, la stessa essenza dell’etica cristiana.
Tuttavia, con e dopo Cartesio, questo tema è stato colpito da una grave ambiguità, di cui la teologia morale non è sempre stata sufficientemente consapevole.
Le due caratteristiche, infatti, fondamentali del pensiero moderno, se non vado errato, mi sembrano le seguenti: a) oggetto della filosofia è essenzialmente ed in primo luogo l’uomo come coscienza pensante e, dunque, l’ambito del filosofare è costituito dalla interiorità; b) quantunque la coscienza pensante sia una certezza indubitabile, si a deve però domandare quale ne sia il funzionamento, la portata ed i limiti e, dunque, l’intenzione dominante della filosofia è la criticità.
Una riflessione completa su queste due verità o dati della filosofia moderna — interiorità e criticità — ci porterebbe molto al largo e devo accontentarmi di alcuni accenni essenziali.
Per quanto riguardo il primo concetto si può dire che l’interiorità è ricondotta esaustivamente alla soggettività. Che cosa significa questa riconduzione? Significa, sostanzialmente, la riduzione o riconduzione della Verità entro i confini dell’umano; significa istituire una perfetta adeguazione del razionale col vero e del vero col razionale. L’interiorità è la pura immanenza della Verità nell’uomo, per cui nulla obbliga la ragione o esige da essa che si trascenda. Se questa è l’interiorità, la criticità, coerentemente, consiste nel mostrare la non pensabilità-conoscibilità di ciò che non è pienamente riconducibile alla misura della ragione umana. Anzi, di conseguenza, la criticità finisce col definire il pensare stesso, perché il pensare consiste precisamente nel ricondurre la verità ai limiti della ragione.
Questo concetto ed esperienza di interiorità ha avuto come esito di non secondaria importanza la ridefinizione di un dato che la cultura occidentale aveva ricevuto dalla predicazione evangelica, quello della mediazione imprescindibile della coscienza morale nell’ambito dell’agire morale dell’uomo.
Posta, infatti, in quel contesto, l’idea cristiana è stata costretta ad assumere i seguenti contenuti: a) è nel giudizio della coscienza morale che la Verità di una norma morale si istituisce e, quindi, questa verità è pienamente in-manente nel giudizio della coscienza; b) qualunque forma di obbedienza ad una autorità di insegnamento morale e di riferimento al medesimo, da parte della coscienza, assume necessariamente il carattere di un formalismo legalista indegno dell’uomo e distruttivo di una vera moralità. (Hegel, come si sa, pensa che sia stato Lutero il primo a percepire questa contraddittorietà fra coscienza ed autorità, iniziando così l’epoca moderna.
Come si vede, il problema si incunea nel groviglio intricato del centro stesso della cultura moderna. E per essere risolto, esige il ricupero di una concezione integrale della interiorità, nel contesto del rapporto originario dell’uomo colla Verità.
Interiorità, in questo senso, è presenza della Verità nell’uomo, ma non è essa stessa la Verità. Si tratta di una “interiorità oggettiva” (Sciacca), perché implica la, anzi è costituita dalla presenza della Verità e Bene Assoluti: la misura dell’interiorità è l’incommensurabilità dell’Essere. L’interiorità oggettiva è, come tale, trascendenza, ascolto umile della Verità e consenso libero al Bene, che è in essa, ma senza identificarsi con essa.
Ancora una volta, si può vedere come l’antropocentrismo non possa essere il principio architettonico della ragione teologica, poiché il passaggio dalla trascendalità alla trascendenza è teoreticamente impossibile.
Nel contesto di questo ricupero della verità intera della interiorità, si ha la vera criticità. Essa implica i seguenti elementi fra loro correlati: a) la consapevolezza che la Verità è donata al pensiero e non da essa posta; b) la ragione elabora giudizi veri per la Verità che rende valido ogni giudizio vero, senza che la Verità prima che è lume dell’intelligenza, sia essa stessa giudicata dall’intelligenza (cfr. De Veritate q.10,146): essa ne è al contempo e trascesa ed abitata; c) pensare criticamente significa lasciarsi pervadere da questa Verità; agostinianamente è “convertirsi ad essa”; “lo spirito non è al di sopra della Verità, ma al di sotto; esso è tenuto non a dissertare su di essa, ma a venerarla” (Newman).
L’interiorizzazione della Verità non è essa stessa la Verità. “Il credente deve far propria la Verità, ma questa preesiste oggettivamente a questa appropriazione. La fede consiste appunto nell’accogliere in noi la verità; ma essa può trasformarci progressivamente in Figli di Dio solo perché si tratta della verità che viene da altrove, dal Cristo e dal Padre; è perché si tratta della rivelazione di Gesù Cristo; il figlio del Padre” (I. de la Potterie).
2,2. È in questo contesto, credo, che si può cogliere il fondamento dell’autorità vera e propria con cui il Magistero si rivolge alla coscienza morale del fedele.
Non separando, come già si è detto, il suo aspetto formale dal suo contenuto o oggetto, il Magistero deve essere considerato come il testimone autentico della Verità-Comandamento che è Cristo, testimonianza che implica anche l’insegnamento di norme morali razionali, come si è già detto. La coscienza morale è, se così posso dire, l’organo attraverso il quale il credente fa sua quella Verità-Comandamento, in quanto diviene la sorgente, il principio delle sue scelte.Ma, poiché si tratta della Verità-Comandamento che è Cristo, questa le rimane sempre trascendente e ad essa la coscienza morale è costitutivamente intenzionata. Si tratta, appunto, di una interiorità oggettiva. Questo rimando non avviene solo col riferimento ad un’epoca storicamente finita, testimoniata da documenti scritti, ma attraverso la mediazione del ministero che ha il potere di rappresentare esso stesso la Verità-Comandamento mediante l’annuncio del Vangelo e la celebrazione dell’Eucaristia.
Contrapporre, o anche semplicemente giustapporre, l’interiorizzazione della Verità da parte della coscienza e la testimonianza oggettiva resa ad Essa dal Magistero implica e comporta o la tendenziale riduzione della interiorità alla soggettività o, dal punto di vista più teologico, la tendenziale separazione dalla forma pneumatica della coscienza morale del credente dal suo contenuto cristologico. In una parola: data la natura propria della interiorità umana e cristiana, data la struttura della Verità-Comandamento, dato il rapporto ad Essa e della interiorità e del Magistero, la coscienza è intrinsecamente obbligata al Magistero medesimo.
D’altra parte, però, risulta coerentemente, che nessuno, all’infuori del Magistero può avanzare nei confronti della coscienza una simile esigenza: né l’esperto in problemi morali (il teologo) né un potere come tale. Solo il Magistero, perché, legato sacramentalmente al Cristo, testimonia alla coscienza quella Verità per cui essa è fatta e che, quindi la libera. Ed è per questo che il Magistero la obbliga in senso vero e proprio: la obbliga in ragione della Verità che annuncia a cui la coscienza è obbligata.
3. MAGISTERO E RICERCA ETICA
Noto subito che il tema di questa terza parte non sono i rapporti fra Teologia e Magistero in generale, ma fra Magistero e ricerca etico-teologica. È necessario, pertanto, che si definisca preliminarmente che cosa intendiamo per ricerca.
Il termine ricerca connota quell’aspetto del teologare consistente nello sforzo di rispondere alle nuove questioni morali che oggi vengono poste dall’uomo: nuove nel senso che nascono da un mutamento che l’uomo ha vissuto nella coscienza di se stesso, da una diversa esperienza del suo essere. È, insomma, la messa in atto di quanto il Santo Padre Giovanni Paolo II ebbe a dire nella sua visita alla Università Gregoriana il 14 dicembre 1979, parlando della necessità per la Teologia “di tenersi in contatto stretto con tutte le ricerche che, nel corso dei tempi, modificano la visione che l’uomo ha di se stesso e del mondo che lo circonda”.
Per la natura stessa di questo necessario momento della riflessione etico-teologica, non è raro oggi il richiamo alla “libertà di ricerca” intesa e come condizione indispensabile per la ricerca stessa e come esigenza che non rende più essenziale al pensare teologico un riferimento al Magistero. E ciò in ragione della novità stessa dei problemi che la ricerca affronta. Anzi, non manca chi parla di un “diritto al dissenso” inerente alla ricerca teologica nei confronti del Magistero: il diritto cioè di offrire soluzioni in contrasto con quanto il Magistero fino ad ora ha insegnato.
E con questo penso di aver sufficientemente delimitato l’ambito della ricerca di questa ultima parte.
3,1. Per muoverci in questa problematica, la prima cosa da farsi, mi sembra, è di precisare il concetto di libertà di ricerca. Per una duplice serie di motivi fra loro connesse.
A) La connessione libertà-verità è un “topos” centrale nella cultura moderna e contemporanea, anzi, secondo molti, è il “topos” centrale. Questa connessione non può qui essere mostrata. Presupposta, essa ci costringe a fare alcune riflessioni essenziali. (a) L’essenza profonda della verità, come svelamento del reale, consiste nella possibilità che l’uomo ha di aprirsi al mistero dell’Essere che fonda l’esistente e si dona attraverso esso; (b) questa docilità all’essere non è pura passività, ma un atto di libertà radicale, anzi il fondamento ultimo della libertà; (c) libertà e verità si richiamano a vicenda in quanto, da una parte, la sottomissione docile al mistero dell’essere è ciò che consente ad esso di svelarsi e, dall’altra, lo svelarsi dell’essere, la verità, è ciò che garantisce la pienezza della realizzazione personale dell’uomo (cfr. Discorso di Giovanni Paolo II su san Tommaso del 17 novembre 1979, n.9, cpv.2).
B) Alle nuove questioni, la teologia morale è chiamata a rispondere come teologia, nella salvaguardia cioè del suo statuto epistemologico di “fides quaerens intellectum”. La preoccupazione metodologica non è pura astrazione, ma riflette la intenzione del teologo a fare uso di una ragione che non impedisca lo svelarsi del Mistero. Una ragione la cui struttura epistemologica è dettata dal suo Oggetto. L’Oggetto della Teologia Morale è il Mistero di Dio, quale definitivamente si rivela nel Cristo che dona se stesso sulla Croce, in quanto questo Mistero è il “Nuovo Comandamento” donato al credente (amatevi come io vi ho amati). Questa Rivelazione è donata alla Chiesa, costituita attreverso la predicazione apostolica fissata nella Scrittura.
Pertanto, è nella Chiesa, nella sua Tradizione della vita e della Verità, che noi possiamo percepire sempre più profondamente il senso del Nuovo Comandamento. E questa Tradizione è costantemente giudicata, o comunque giudicabile quando se ne presenti l’occasione, dal Magistero. Esso è profondamente radicato nella coscienza della Chiesa, col compito di renderla sempre più consenziente alla Verità di Cristo ed alle esigenze del suo Comandamento.
Tenendo dunque presente questa duplice serie di considerazioni, possiamo tentare di definire il concetto di libertà di ricerca. Esso mi sembra costituito dai seguenti elementi.
a) Libertà di ricerca significa togliere dal proprio spirito tutto ciò che impedisce alla Verità, che è la donazione di Cristo, di svelarsi in tutte le sue esigenze, attraverso l’accoglienza totale della, il consenso radicale alla fede della Chiesa, uscendo da ogni personalismo. È, per questo, io credo, che non ci sia condanna più grave nei confronti dell’opera di un teologo, anche geniale, che quando si dice che le sue opere ci permettono di conoscere il suo pensiero. L’opera del vero teologo deve permetterci di conoscere non il pensiero di questo teologo in ciò che esso ha di individuale, di particolare, ma la Noûs Christou, quel pensiero di Cristo che la mens Ecclesiae, cioè il pensiero della Chiesa solamente ci trasmette e conserva viva per noi. (L. Bouyer, Le métier de théologien, Paris 1979, p.208-209).
b) È un puro pregiudizio ereditato dall’Illuminismo e spesso acriticamente accolto, quello di ritenere che la libertà di ricerca comporti un punto di partenza assoluto da ogni punto di vista.
Già dal punto di vista del pensare semplicemente umano, la cosa si presenta piuttosto con i caratteri di una retorica della liberté che di un pensare autentico. Si pensi, infatti, solo per fare un accenno, al legame fra pensiero e linguaggio appreso.
Dal punto di vista poi teologico la cosa è assolutamente priva di senso. La Verità, che la teologia morale è chiamata a pensare, si dona, precedentemente ad ogni riflessione critica, al fedele nella vita della Chiesa, dei Santi in particolare, Ed è soltanto a partire da questa vita, da questa fede normativamente istruita dal Magistero, che la ricerca etico-teologica, come ogni ricerca teologica, può sperare di attingere conoscenze più profonde.
c) Libertà di ricerca significa, allora, distacco critico nei confronti anche delle domande o problemi che oggi si pongono. La Verità di Cristo è critica non solo nei confronti delle risposte, ma anche delle domande spesso. Essa non accetta tout court le nostre questioni, le trasfigura, le apre alle dimensioni della verità intera dell’uomo, rivelataci da Cristo, conducendoci così alle vere questioni cui Essa risponde. “La vera libertà universitaria deve essere considerata nella sua relazione fondamentale con lo scopo finale del lavoro universitario che tende alla verità totale della persona umana” (Giovanni Paolo II, 7/10/79, in DocCath. n°1773, p.944).
d) E siamo così al nucleo centrale del concetto di libertà di ricerca: libertà di ricerca significa porci e rimanere dentro la Verità che ci fa liberi, Verità che è Cristo e che si dona nella forma ecclesiale della fede, e da questo punto di vista conoscere tutto il resto.
3,2. Abbiamo cercato di schizzare un concetto teologico di libertà di ricerca. Si tratta ora di considerare il rapporto fra Magistero e ricerca.
Si deve fare attenzione a non ridurre questo rapporto ad un problema di composizione di due diritti aventi ciascuno un proprio ambito da salvaguardare. Se questa dimensione del problema non può essere ignorata del tutto, in quanto nella Chiesa son pur sempre possibili dei conflitti, essa tuttavia non è né l’unica né la principale.
Una simile impostazione soffre di una profonda ambiguità che il concetto moderno di diritto soggettivo, data la sua genesi storica, porta con sé. Questo concetto nasce infatti dal presupposto di una difesa del singolo nei riguardi della società e dell’autorità in particolare. Trasferire questa concezione all’interno della teologia può creare solo confusione.
Più che di diritto, inteso in questo senso (potere di... difesa da... contro...), nel caso del teologo si deve parlare di libertà che è umile consenso ed obbediente apertura alla Verità, che è Cristo, vivente nella Chiesa, garantita dalla successione apostolica; nel caso del Magistero, di legame, vincolazione alla regola cristo-pneumatologica, per cui esso non parla a nome proprio, ma testimonia ciò che gli Apostoli hanno ascoltato o trasmesso, assistito dallo Spirito.
Da ciò consegue che: a) la libertà della ricerca è precisamente assicurata e resa possibile dalla successione apostolica, in quanto questa impedisce il venir meno della Verità, della vita della Verità nella Chiesa; b) la fedeltà al Magistero impedisce di “mascherare” l’affermazione della propria soggettività con la maschera della libertà della ricerca, in quanto questa fedeltà istituisce, sul piano oggettivo, l’inserimento del proprio punto di vista nella totalità, nella cattolicità, diacronica e sincronica della fede della Chiesa, luogo in cui la Verità del Comandamento si dona e si svela; c) la libertà di ricerca esige il rispetto dei fedeli ed il loro diritto “di non essere turbati da teorie ed ipotesi che non sono in grado di giudicare o che possono essere facilmente semplificate o manipolate dall’opinione publica per fini estranei alla Verità” (Giovanni Paolo II, disc. cit.).
Tutto questo vale non in minor grado, quando la ricerca etica si muove nell’ambito della “legge naturale”. In questo ambito infatti, è più facile che le questioni poste, anche quelle più profondamente vere, siano falsificate o deviate dalla situazione decaduta in cui versa l’uomo. È solo il confronto critico con la misura intera della verità dell’umano, che è Cristo, che può salvare la ricerca etica da ogni forma di riduzione di questa misura. E solo questo confronto può impedire un pensare per contrapposizioni anziché per successive integrazioni di punti di vista superiori, convergenti verso la pienezza del Comandamento che è Cristo.
Dal punto do vista pratico, la Chiesa ha dovuto regolare, anche giuridicamente, il rapporto di cui stiamo discutendo. Non è mia competenza addentrarmi in questo aspetto del problema. Vale anche per esso, che è un frammento della vita ecclesiale, la stessa regola di intelligenza: acquista senso nel tutto, nel tutto che è la Verità e la Vita di Cristo, la quale si espande nella totalità organica del suo Corpo che è la Chiesa.
CONCLUSIONE
Ho tentato di rispondere alla problematica postami, inserendola nel complesso delle connessioni o correlazioni teologiche più profonde da cui nasce, sforzandomi di situarla storicamente nella problematica posta dalla cultura di oggi.
Il dibattito potrebbe precisamente svolgersi a questo livello, mettendo in atto quella “analogia fidei” o “sinfonicità della Verità” che genera il sapere della fede.
|