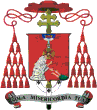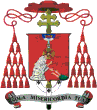«Ratio technica/ratio ethica»
Contributo al Seminario di Studio «Teologia e scienze nel mondo contemporaneo» della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino “Angelicum”, Roma, 1° marzo 1989
Pubblicato sulla rivista Anthropotes, maggio 1989
La nostra riflessione sui rapporti fra «ratio technica» e «ratio ethica» prende avvio dalla definizione-distinzione, compiuta rigorosamente da Aristotele nell’Etica Nicomachea [nota 1: Sulla questione se sia stato Aristotele a intuire per primo questa distinzione, ad elaborarne la valenza nell’ambito etico, si può vedere quanto scrive R.A. Gauthier - J.Y. Jolif, L’Ethique à Nicomaque, II, 2, Louvain-Paris 1970, 456-457], fra «techne» e «phronesis» [nota 2: È rimandata più avanti la questione se la distinzione aristotelica è esattamente coestensiva alla distinzione ratio technica - ratio ethica].
Accennata già nel prologo (1094 a, 4), essa viene elaborata esplicitamente e chiaramente in VI, 4, 1140 a-5 - 1140 b-30. Volendo sintetizzare, mi sembra che gli elementi essenziali del discorso aristotelico siano i seguenti.
- Esiste una differenza essenziale fra «produzione» (ποίησις) ed «azione» (πράξις), così che nessuna può essere inclusa nell’altra come specie nel genere.
- La differenza essenziale consiste nel fatto che la produzione ha come suo oggetto un termine che non è la produzione stessa (l’oggetto della costruzione di una casa non è l’attività costruttiva stessa, ma la casa); al contrario l’azione ha come suo oggetto-termine l’azione stessa. Pertanto, le due attività corrispondono alla distinzione fra κίησις ed ἐνίργεια di cui in Metafisica VI, 6, 1048 b, 18-36.
- Ai due modi suindicati di esercitarsi della ragione pratica corrispondono due attitudini permanenti (abiti) essenzialmente diversi: alla produzione corrisponde la tecnica, all’azione corrisponde la saggezza (la prudentia).
Il richiamo ad Aristotele è per ora sufficiente. Riprendiamo ora i testi del filosofo greco, nell’interpretazione data da san Tommaso in Sententia Libri Ethicorum. È necessario premettere al commento del libro VI l’inizio del commento, per l’importanza che riveste — come vedremo — per la nostra riflessione.
«Ordo... quadrupliciter ad rationem comparatur. Est enim quidam ordo quem rado non facit, sed solum considerat, sicut est ordo rerum naturalium, Alius autem est ordo, quem ratio considerando facit in proprio actu, puta cum ordinat conceptus suos ad invicem... Tertius autem est ordo quem ratio considerando facit in operationibus voluntatis. Quartus autem est ordo quem ratio considerando facit in exterioribus rebus, quarum ipsa est causa, sicut in arca et domo» (Lib. 1 lc. 1, n° 1).
Il rapporto che Tommaso istituisce fra ordo e ratio è pensato in questo testo, dal punto di vista dell’efficienza della ragione. La ragione è considerata in quanto causa-principio che «fa ordine», semplicemente col suo atto (considerando) [nota 3: Esula dal presente studio una prolungata riflessione sul concetto di ordine. Rimandiamo a J.J. Sanguineti, La filosofia del cosmo in Tommaso d’Aquino, Milano 1986, 27-93]. E si può subito osservare che nei confronti dell’ordine, la ragione è passiva e attiva. Esiste un ordine non posto in essere dalla ragione, un ordine che le preesiste: è l’ordine metafisico (ordo rerum). Esistono ordini costituiti dalla ragione: l’ordine logico, l’ordine nell’esercizio della volontà (ordo agendi) e l’ordine nelle produzioni (ordo faciendi). Limitandoci agli ultimi due, al par. successivo, Tommaso specifica ulteriormente la distinzione fra essi, aggiungendo che le «res exteriores» sono costituite per mezzo della ragione (constitutis per rationem). È, dunque, chiaro che gli ultimi due campi in cui si esplica l’azione ordinatrice della ragione corrispondono alla prassi (azione) e alla produzione di cui parla Aristotele. Vediamo, pertanto, le riflessioni di Tommaso sul libro sesto dell’Etica Nicomachea, esponendole sinteticamente, tenendo conto soprattutto degli approfondimenti originali.
- La differenza essenziale fra la produzione (factio) e l’azione (actio) è collocata nel rapporto differente che esse hanno con la persona umana: la prima non perfeziona la persona umana come tale, ma semplicemente esprime una sua capacità di fare bene qualcosa (una casa, un utensile...; cfr lib. 6, lc. 3, n. 10, 13-14; lc. 4, n. 7); la seconda perfeziona la persona umana come tale, poiché il termine o effetto dell’azione è intrinseco al soggetto agente stesso (principium generationis artificialium operum est in solo faciente, quasi extrinsecum ab eis, sed non in facto quasi intrinsecum; ibid., n. 14). La produzione, infatti, è sempre operari circa materiam exteriorem (ibid., n. 13). In una parola: produrre è esteriorizzarsi, agire è interiorizzarsi.
- La differenza essenziale dell’oggetto fonda ed esige due attitudini essenzialmente diverse nella persona: ars e prudentia [nota 4: Sono ben note a tutti le difficoltà che si incontrano oggi nel tradurre questi due termini tecnici nel linguaggio etico medioevale. Arte: con questa traduzione si rischia semplicemente l’equivoco; prudenza: con questa traduzione si rischia di impoverire o forse di evacuare completamente il contenuto del termine latino. Da parte mia, d’ora in poi traduco ars con abilità tecnica e prudentia con saggezza]. L’abilità tecnica dispone l’uomo a produrre bene, cioè ad effettuare prodotti che sono perfetti (capaci di servire per lo scopo per cui sono fatti). La saggezza dispone l’uomo ad agire bene, cioè a compiere quelle scelte che sono conformi al bene della persona come tale. E ancora una volta, la riflessione tomista mi sembra insistere soprattutto nel rapporto che le due attitudini spirituali intessono colla persona umana (cfr soprattutto la lc. 4 e anche 1, 2, q. 57, 3-5 e De Virtutibus in communi, a. 3). L’abilità tecnica rende l’uomo capace solo di produrre; la saggezza rende l’uomo buono: ars non perfecit hominem ex hoc quod bene velit operari secundum artem, sed solummodo ad hoc quod sciat et possit (De Virtutibus..., cit., in corpore). Il bene a cui è ordinato l’esercizio della saggezza è il bene della persona.
La riflessione, però, più importante nei testi tomisti riguarda un problema già presente nella teoresi aristotelica, ma nella quale esso non aveva ricevuto una risposta sufficientemente chiara [nota 5: Su questo si veda la presentazione sintetica di R.A. Gauthier - J.Y. Jolif, L’Etique.., cit., 563-578].
Si tratta di questo. Aristotele aveva finemente percepito che la decisione (πρoαίρεσις) è la sintesi vissuta, l’incrociarsi esistenziale della volontà (βoύλησις) e del giudizio prudenziale; la decisione è l’intelletto giudicante e ordinante (έπιτακτική: EN VI, 11, 1143 a. 8) sotto la mozione della volontà (si veda: EN III, 1-6; ed anche Il movimento degli animali V; Dell’anima III, 10) [nota 6: 6 Normalmente, gli studiosi di Aristotele esprimono questo punto centrale dell’Etica aristotelica sotto la forma del sillogismo (pratico). (M): si deve agire con temperanza, (m): ma questo atto è un atto di temperanza, (C): dunque, decido di compiere questo atto. Come nel sillogismo speculativo, la conclusione non è altro che la connessione della M. colla m., così la decisione è la connessione fra l’atto della volontà retta che vuole il valore della temperanza e l’atto della ragione che giudica fra i vari atti possibili quale è l’atto temperato, cioè sussumibile nella intenzione della volontà temperante. Ed Aristotele può coerentemente affermare che la verità del giudizio saggio consiste nella conformità alla volontà retta]. Questa struttura e genesi della decisione pone un problema assai importante che Tommaso nel Commento pone in questi termini:
«…si veritas intellectus practici determinatur in comparatione ad appetitum rectum, appetitus autem rectitudo determinatur per hoc quod consonat rationi verae, ut prius dictum est, sequetur quaedam circulatio in dictis determinationibus» (lib. 6, lc. 2, n. 8).
La soluzione data o risoluzione di questa «circulatio» fra la verità della ragione pratica e la rettitudine della volontà, nel Commento all’Etica, è cercata e posta nell’affermazione della relazione naturale (precedente cioè ogni decisione libera) della volontà al suo fine: finis autem determinatus est homini a natura (ibid.). La sorgente ultima della vita etica starebbe, dunque, in questa naturale ordinazione al fine. Il resto, determinazione di ciò che conduce al fine, è opera della ragione alla quale deve conformarsi la volontà di ciò che conduce al fine. Dunque: si dà una priorità (una misurazione) del volere naturale nei confronti della ragione sul piano del fine; si dà una priorità (una misurazione) della ragione nei confronti del volere decidente sul piano dei mezzi. Non è chi non veda che la soluzione tomista può prestare il fianco ad una seria obiezione, quella di far scaturire tutta la vita etica dell’uomo da un fatto pre-etico (naturale).
Se leggiamo attentamente l’opera contemporanea, il De Virtutibus in communi, all’art. 7 notiamo una significativa affermazione: praesupposito enim a voluntate fine boni, prudentia perquirit vias per quas hoc bonum et perficiatur et conservetur, ove sembra che la determinazione del fine sia opera della volontà. Nell’altra opera contemporanea, la Secunda secundae, all’art. 6 della quaestio 47, la priorità è attribuita, anche nell’ordine dei fini, esplicitamente alla ragione (sinderesi: ibid., ad 1um). Il fine (ciò che è virtuoso) delle virtù morali preesiste sia alla saggezza sia alla virtù, nel senso in cui i principi preesistono alle conclusioni. È la ragione pratica che naturalmente conosce ciò che è virtuoso: l’atto che è giusto, che è temperato, che è forte. In questo senso, nell’ad 3um, Tommaso usa un’espressione assai precisa e vigorosa: non sono neppure le virtù che determinano ciò che è bene / ciò che è male, ma solo la ragione (finem a ratione naturali praestitutum). In questo contesto, la funzione della saggezza è disporre qualiter et per quae homo in operando attingat medium rationis (II-II, q. 47, a. 7).
Ma, nella Prima secundae (q. 89, a. 6), Tommaso pone come primo atto da cui scaturisce tutta la vicenda spirituale dell’uomo, un atto di volontà descritto come «deliberare de seipso» o «seipsum ordinare in ordine ad debitum finem», per cui la determinazione (la praestitutio) del fine ultimo è opera di un atto libero.
È possibile, cercando più in profondità, trovare una armonia interna a queste posizioni che sembrano carenti di una coerenza intima?
Al fine di cogliere questa coerenza è necessario tenere presente la distinzione fra la causalità formale, a cui corrisponde l’ordine dell’apprensione razionale e la causalità efficiente, a cui corrisponde l’ordine dell’esecuzione libera: la priorità della ragione nei confronti della volontà si dà nell’ambito della causalità formale, la priorità della volontà nei confronti della ragione si dà nell’ambito della causalità efficiente. Detto in altri termini: la facoltà che giudica ciò che è bene / ciò che è male, è la ragione; la facoltà che compie ciò che è bene / ciò che è male, è la volontà.
Il concetto è espresso in modo assai stringato e profondo nell’ad 2um, art. 7, q. 47 della II-II:
«Sicut agens naturale facit ut forma sit in materia, non tamen facit ut formae conveniat ea quae per se ei insunt, ita etiam prudentia medium constituit in passionibus et operationibus, non tamen facit quod medium quaerere conveniat virtuti».
L’atto umano viene all’essere, in possesso di una specifica sua forma: il suo essere è dovuto alla volontà (perfezionata dalla virtù), la sua forma (e la sua specie morale) non è dovuta alla volontà, ma alla ragione (perfezionata dalla prudenza). Più precisamente: al rapporto fra l’atto come tale e la ragione.
Questa riflessione ci conduce finalmente a cogliere la terza e più profonda differenza fra ragione tecnica e ragione non-tecnica. Ed in questo Tommaso — come sempre — si colloca oltre Aristotele, in modo originale. Penso che l’espressione più chiara di questa intuizione si abbia nel De Veritate (q. 1, a. 2).
Volendo esprimere il rapporto fra la realtà creata e l’intelletto divino, l’Aquinate usa l’analogia del fare tecnico [nota 7: È ritornante in Tommaso questa analogia, quando parla dell’atto creativo]: in esso, infatti, è la ragione del tecnico che «misura» la realtà prodotta, così che il rapporto di cosa prodotta a ragione tecnica è rapporto di «misurato» a «misurante». Ciò che Tommaso vuole escludere dall’atto creativo, servendosi di questa analogia, è la benché minima dipendenza del Creatore — del suo intelletto — dalla creatura. Il concetto, quindi, di «misura» non ha nel suo linguaggio il significato che ha nel nostro comune linguaggio: esso (termine) connota la dipendenza costituente la forma, cioè la dipendenza in ciò che la realtà è, dalla ragione. E pertanto, Tommaso nel testo del De Veritate esclude che si possa parlare di una misurazione compiuta dall’intelletto umano nei confronti delle res naturales (intellectus noster est mensuratus, non mensurans quidem res naturales, sed artificiales tantum), poiché è da escludere ogni causalità (efficiente) dell’intelletto creato nei confronti delle res naturales. È l’aria che è luminosa o oscura: è l’intelletto che è vero o falso; ma non è l’aria che causa la sua luminosità, ma il sole: non è l’intelletto la causa della verità, ma l’ente (illud quod est in aliquo non sequitur illud in quo est, nisi quando causatur ex principiis eius... veritas quae in anima causatur a rebus non sequitur aestimationem animae, sed existentiam rerum). In sintesi: la ragione tecnica causa la (verità della) cosa prodotta; l’ente causa la verità della ragione speculativa.
Ma, da tutto quanto si è detto finora, risulta in primo luogo che la ragione pratica non è riconducibile esaustivamente alla ragione tecnica (e questo è già chiarito pienamente in Aristotele); in secondo luogo, che la funzione tecnica della ragione pratica è di specie diversa dalla funzione etica (la ratio practica technica è di specie diversa dalla ratio practica ethica: e anche questo è già esplicitamente affermato in Aristotele); in terzo luogo, che la ratio ethica non causa l’atto umano considerato nella sua specifica forma morale, non causa la bontà/malizia dell’atto (è l’apporto tomista al problema).
Posto questo background alla nostra riflessione, vorrei ora verificare l’ipotesi secondo la quale la crisi in cui versa l’attuale riflessione etica ha una sua ragione non ultima nella progressiva identificazione-riconduzione della ratio ethica alla ratio technica. In un secondo momento, vorrei cercare di individuare le ragioni di questa identificazione-riconduzione.
1. La negazione della differenza specifica
Vorrei partire da una presentazione sintetica dell’utilitarismo dell’atto, nel quale vedo la più radicale identificazione della ragione tecnica colla ragione etica.
Secondo G. Pontara [nota 8: In Filosofia pratica, Milano 1988, 255. Il saggio è una versione di quello incluso nel volume Utilitarismo oggi (a cura di E. Lecaldano - S. Veca), Bari 1986], come teoria etica, l’utilitarismo dell’atto può essere ridotto a tre principi fondamentali.
P 1: un atto è moralmente retto se, e solo se, non vi è alcuna altra alternativa che produca un totale maggiore di felicità.
P 2: un atto è moralmente doveroso se, e solo se, esso produce un totale di felicità maggiore che quello prodotto da ogni altra alternativa.
P 3: un atto è moralmente ingiusto se, e solo se, vi è una qualche altra alternativa che produce un totale maggiore di felicità.
Non sarà del tutto inutile, per capire questa teoria etica, scoprirne l’intima struttura teoretica. Essa implica, in primo luogo, una teoria teleologica, sul fine cioè dell’agire umano collocato nella «felicità»; di conseguenza, il criterio in forza del quale si discrimina l’atto retto dall’atto ingiusto è individuato nella capacità rispettivamente produttiva-improduttiva di felicità. L’elezione, pertanto, giusta è quella coerente ad una deliberazione che consiste in un bilanciamento o confronto fra gli effetti dell’atto: l’alternativa, cioè, non si pone fra due o più atti, ma fra le conseguenze (in termini di felicità-infelicità) di due o più atti, oggetti possibili dell’elezione [nota 9: Si deve evitare di cadere nell’equivoco di pensare che vi sia una benché minima analogia fra il teleologismo utilitarista e il teleologismo di san Tommaso, che pure fonda la sua teoria etica sull’individuazione del fine ultimo dell’uomo (come, per altro, anche Aristotele: cfr EN, Lib. I). I due termini significano qualcosa di completamente diverso]. Ciò che deve essere notato in questa definizione descrittiva dell’utilitarismo dell’atto sono i due elementi costitutivi del medesimo.
In primo luogo, la negazione della possibilità teoretica di qualificare eticamente l’atto umano solamente in ragione del suo oggetto. È un punto centrale. Nonostante affermazioni contrarie, fatte recentemente da alcuni teologi moralisti cattolici [nota 10: Cfr C. Curran - R. Mc Cormick, Readings in Moral Theology, N° 1, New York 1979, 158-183], il pensiero di Tommaso al riguardo è esplicito (cfr per es. I-II, q. 18, a. 2). Esistono atti che semplicemente ed esclusivamente in ragione di ciò che li definisce, se fatti oggetto di una volontà libera, rendono ingiusta questa volontà perché la rendono irragionevole; adulterio, contraccezione, omicidio, per esempio. La negazione dell’esistenza di atti di questo genere, è la prima e fondamentale caratterizzazione dell’utilitarismo dell’atto, sotto qualsiasi forma esso si presenti.
In secondo luogo, e di conseguenza, il giudizio etico dovrà essere spostato in avanti, oltre l’atto come tale: sulle sue conseguenze. E poiché è praticamente impossibile che l’atto umano abbia solo conseguenze univocamente finalizzate, il giudizio etico consiste formalmente in un giudizio di misurazione-confronto (bilanciamento) fra effetti di una specie ed effetti di un’altra. Ma è precisamente a questo punto che ogni forma di utilitarismo cade in aporie insuperabili. In base a quale criterio si specifica un effetto (qualificandolo come buono) nei confronti di un effetto specificamente contrario (qualificato come cattivo)? Nella presentazione dell’utilitarismo da cui siamo partiti, tale criterio è alla fine collocato nel calcolo totale della felicità ottenuta. In realtà, nonostante l’apparente semplicità della risposta, questo criterio o è inapplicabile o è un «passaggio in altro genere». È inapplicabile: non si potrà mai sapere con certezza quale sarà l’effetto conseguente all’atto, essendo, per definizione, esso semplicemente prevedibile, cioè congetturabile nella sua contingenza [nota 11: Normalmente, l’utilitarista dell’atto sussume che non si può chiedere una certezza al sapere etico che vada oltre la validità generale, cioè la probabilità (valet ut in pluribus). «È l’usanza dell’errore, darsi a intendere d’avere scelto il posto dov’è stato cacciato, e chiamare inutile o impossibile ciò che non può dare» (A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, Appendice al cap. III, in Opere, vol. II, Firenze 1973, 1433ss.). Ma il dire ciò significa semplicemente dire che non esiste affatto un sapere etico, ma solo delle congetture o ipotesi etiche. Se il criterio del giudizio etico è tale che, applicato, porta solamente a proposizioni, alle quali bisognerebbe sempre premettere «forse sl/forse no), non sarebbe più razionalmente lecito parlare di una verità sul bene e sul male. «Il dubbio parziale e accidentale limita la scienza; il dubbio universale e necessario la nega» (A. Manzoni, ibid.). Più avanti vedremo la conclusione cui, coerentemente, giungerà Sidgwick (nota 13)]. È «passaggio in altro genere». Delle due l’una: o la moralità dell’atto è desunta dagli effetti effettuati in quanto effettuati, o è desunta dagli effetti effettuati in quanto calcolati-previsti. Nel primo caso, la moralità dell’elezione dipenderebbe completamente da ciò che non dipende, per definizione, dall’elezione: il genus moris — direbbe san Tommaso — dipenderebbe dal genus naturae. Nel secondo caso, la moralità dell’elezione sarebbe non una qualità dell’elezione stessa, ma della ragione esattamente calcolante; il male è l’errore di calcolo, il bene è la verità del calcolo. In ambedue i casi, si ha sempre un passaggio in altro genere, cioè semplicemente la negazione che le proposizioni etiche siano dotate di un loro peculiare significato e l’evacuazione dell’esperienza etica.
I due difetti inerenti al criterio utilitarista-consequenzialista (inapplicabilità-conduce in un altro genere), sono conseguenza di ciò in vista di cui quel criterio è stato posto: il fine della felicità (individuale e/o generale). È questo concetto stesso che è incapace, teoreticamente e praticamente, di costituire fondamento di una teoria etica.
Incapacità teoretica, in primo luogo. L’utilitarista parla (coerentemente) di un totale maggiore di felicità, alternativa a un totale minore di infelicità. Si tratta cioè di una somma totalizzante di effetti, di un ragguaglio di effetti buoni e di effetti cattivi che giunge al risultato che il totale o somma dei primi è superiore al totale o somma dei secondi. Ma, in realtà, il «totale» in quanto tale, non esiste in realtà, ma è solo una relazione pensata nella mente. La nostra intelligenza vede in vari effetti di molteplici atti, compiuti in una successione cronologica, una qualità comune, la loro bontà/malizia, e li riferisce all’unità del soggetto da cui sono stati compiuti, in realtà, con successione cronologica. Ora, questa riunificazione è una pura operazione mentale, cui non corrisponde nella realtà altro se non una serie di atti-effetti, distribuiti e separati nel tempo. In una parola: il totale maggiore di felicità è un totale maggiore di felicità rappresentata, non reale [nota 12: Per questa ragione la felicità esclude sia la successione cronologica sia la finitezza del bene beatificante: esige, cioè, l’eterno possesso di Dio stesso. Si vedano le fini analisi di Sant’Agostino, De beata vita, 2, 11.]. E pertanto, fondare il criterio della elezione su questa felicità, in realtà equivale a fondarlo su ciò che in questo momento è probabile che sortisca un buon effetto.
Incapacità pratica, in secondo luogo. Un fine rappresentato e non reale non può sostenere la volontà da non impedirle, prima o poi, di esercitarsi come facoltà chiamata semplicemente a ordinare impulsi e/o emozioni, in ordine a un benessere psicologico, sempre, per sua natura stessa, instabile [nota 13: E, quindi, si deve pienamente sottoscrivere la dichiarazione cui giunge alla fine H. Sidgwick, di aver cercato il Cosmo e di aver trovato il Caos. Cfr A. McIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, Milano 1988 (l’ed. inglese è del 1981 e 1984), 85].
Vorrei ora mostrare come questa teoria etica dell’utilitarismo sia una delle più perfette espressioni della riconduzione della ratio ethica alla ratio technica. Lo farò, ripercorrendo successivamente i vari momenti teoretici precedentemente schizzati.
La negazione dell’esistenza di atti già moralmente qualificabili in base esclusivamente alloro oggetto, è il punto di partenza che per necessità teoretica conduce all’evacuazione della ratio ethica dentro la ratio technica.
Come abbiamo già visto, sia Aristotele sia Tommaso fondano la distinzione fra il fare e l’agire sulla distinzione essenziale fra ciò che è fattibile e ciò che è agibile: li distinguono, cioè, ratione obiecti. Il termine o oggetto del fare non è il fare stesso: il fare è operazione transeunte, finalizzato alla produzione di un effetto. Il termine o oggetto dell’agire è l’agire stesso: l’agire è operazione immanente, finalizzato all’attuazione del soggetto agente. L’omologia fra la definizione classica della tecnica e la definizione (consequenzialista) utilitarista dell’etica balza immediatamente agli occhi: non ci si può tuttavia accontentare di questa immediata constatazione, senza rischiare di cadere in superficiali equivocità. Ma c’è in essa omologia qualcosa di più profondo. Ciò che la definizione classica di agire metteva in rilievo era che la moralità è una qualità intrinseca all’atto stesso, cosi intrinseca che colloca l’atto in un genus essendi nuovo e irriducibile: l’atto adulterino è essenzialmente diverso dall’atto coniugale, pur essendo identico in genere naturae [nota 14: È un insegnamento costante in san Tommaso: 2 Sent., d. 40, a. 1; Contra Gentes, 3, 9; 1, q. 48, a. 1, ad 2; De malo, q. 2, a. 4; I-II, q. 18, a. 5; De virtutibus, q. 1, a. 2, ad 3]. La moralità, infatti, riguarda l’agire in ciò che esso ha di più personale, di più intrinseco all’uomo: il suo essere un atto libero o oggetto di un atto libero. Nulla è più intrinseco all’uomo che il volere; nulla è più intrinseco al volere che il volere liberamente. La giustizia/ingiustizia o sono qualità inerenti alla elezione libera o non sono per niente. Nel sistema utilitarista, in quanto nega la possibilità stessa di qualificare moralmente l’atto esclusivamente ratione obiecti, la moralità dell’atto rimane del tutto estrinseca all’atto stesso: dipende, infatti, non dall’azione, ma da ciò che consegue all’azione. Ora, ciò che consegue all’azione non è per sé più oggetto di elezione, non dipendendo per sé dalla elezione stessa. La bontà dell’agire non può essere conosciuta nell’agire stesso, ma in ciò che l’agire ha prodotto [nota 15: Non si deve cadere nell’equivoco di assimilare queste tesi consequenzialiste colla tesi sulla rilevanza etica delle conseguenze del proprio agire esposta da san Tommaso in I-II, q. 20, a. 5 e testi paralleli. Posto, infatti, il principio nel Sed contra, egli attribuisce in ogni caso alle conseguenze (esclusa quella, ovviamente, che consegue imprevista per accidens) un valore etico addizionale, cioè accidentale, secundum magis vel minus, che non muta la qualità etica inerente all’atto in sé. San Tommaso, infatti, ha già dimostrato nel primo articolo della stessa questione l’esistenza di una moralità inerente all’atto in ragione del suo oggetto].
Certamente, il consequenzialista potrebbe rifiutare la correttezza di questa omologia per la sua tesi di partenza e la definizione di ratio technica, obiettando che la bontà/malizia della conseguenza è teoreticamente fondata sulla relazione fra esse (conseguenze) e il soggetto agente: la transitività dall’agire sarebbe tale solo prima facie, ritornando poi al criterio della immanenza (sempre nel senso classico, non quello della filosofia moderna). Più semplicemente: la conseguenza è buona/cattiva in quanto fa essere/non essere il soggetto agente e inoltre non è escluso che le conseguenze dell’atto accadano nel soggetto agente medesimo.
L’obiezione, in realtà, non ha molta consistenza. Delle due l’una, infatti. O l’essere del soggetto agente, a cui devono essere correlate le conseguenze dell’atto per ricevere la loro qualificazione morale, è considerato come assiologicamente neutrale, e allora il giudizio razionale non è solo ciò mediante cui (principium qua) la ragione conosce l’ordine già dato, esistente fra conseguenze dell’atto e persona, ma ciò che (principium quod) con- stituisce questo stesso ordine [nota 16: «Lo spirito partorisce da se stesso l’atto onde vede il vero, ma partorendo tale atto, non però partorisce quel che vede» (A. Manzoni)]: e questa è precisamente la definizione della ragione tecnica.
O l’essere del soggetto non è assiologicamente neutrale (ens et bonum convertuntur), e allora si deve ammettere che possano esistere atti che lo contraddicono, in ragione della loro pura e semplice posizione (in termini classici: ratione obiecti): e questa è precisamente la negazione del punto cen- trale del consequenzialismo [nota 17: La convertibilità trascendentale (nel senso tomista, non del trascendentale moderno) dell’essere col bene comporta per logica necessità che non ogni atto in sé considerato sia neutrale, dal punto di vista etico. Per negare questa consequenzialità, è necessario dire che comunque tu agisca, è sempre buono l’atto che compi: il che è la negazione pura e semplice dell’etica].
La riflessione ci conduce, così, a una acquisizione teoretica importante. Il principio fondamentale dell’utilitarismo-consequenzialista implica una definizione di ragione pratica, come ragione costitutiva dell’ordine, causa efficiente dell’ordine morale nell’agire umano.
L’implicazione deviene scoperta passando al secondo momento teoretico dell’utilitarismo-consequenzialista: la sua metodologia del giudizio morale, che consiste in un confronto-bilanciamento degli effetti previsti dalle varie scelte possibili e alternative.
Questa metodologia, come già si è visto, è costituzionalmente incapace di generare una certezza e, pertanto, le norme morali non potranno avere una validità universale, ma solo generale: ad ogni norma, si deve sempre pensare che sia presupposto un «nella maggior parte dei casi, si deve ritenere che il dire contrario al pensiero è illecito, che l’adulterio è illecito...». Immaginiamo dunque una persona che voglia deliberare mettendo in atto questo metodo. Ella si trova in un momento in cui il riferimento alla norma morale non ha piu alcuna rilevanza, poiché essa, per definizione, non le dice se può mentire o non mentire ora e qui. Il riferimento alle conseguenze delle due alternative — mentire o non mentire ora e qui — la lascia nella stessa situazione di incertezza, come abbiamo già dimostrato. Compiuto l’atto, le sue conseguenze non appartengono più alla libertà della persona che ha compiuto l’atto: non solo, la norma morale stessa è stata elaborata dalla ragione sulla base delle conseguenze che generalmente seguono alle varie alternative. Dunque, la deliberazione (di mentire/di non mentire) è presa non sulla base di un giudizio razionale che enuncia una verità sul bene/sul male della scelta, ma sulla base di una speranza che la scelta fatta sia buona: speranza che sarà confermata o smentita ad atto compiuto. La deliberazione è una ipotesi da verificare: è uno sperimentare.
Ma continuiamo nel racconto della nostra storia. La persona ha mentito, ritenendo che la bilancia piegasse a favore delle conseguenze della menzogna. Le ipotesi sono due: la sua previsione è stata smentita; la sua previsione è stata confermata. I giudizi che sono possibili da parte della persona sono tre: ho agito male, perché le conseguenze non si sono verificate, ho agito bene perché le conseguenze si sono verificate; ho agito comunque bene, perché queste erano le conseguenze ragionevolmente prevedibili e non dipende dalla persona se poi esse, per fattori che non potevano entrare nel campo delle sue capacità di prevedere, non si sono realizzate. Ora i primi due giudizi implicano che la moralità è condizionata dalla effettività: bonum ipsum factum, la coincidenza cioè del dovere col fatto. Coincidenza che è la negazione pura e semplice dell’etica.
Il terzo implica che la moralità coincide colla capacità calcolante: il male è un errore di calcolo; il bene è la correttezza del calcolo. La persona, infatti, sarebbe moralmente condannabile solo se non avesse previsto ciò che era prevedibile, poiché in questo caso — e solo in esso — fra le due alternative avrebbe scelto quella che si poteva prevedere non avrebbe prodotto un totale di bene, maggiore dell’altra. Ma precisamente in questa scelta consiste il male morale.
Tralasciando altre riflessioni che al riguardo si potrebbero fare [nota 18: Si legga al riguardo tutto il Capitolo secondo della Parte seconda de La malattia mortale di S. Kierkegaard, (in Opere, ed. Sansoni, Firenze 1972, 667-672)], questa definizione di peccato coincide colla definizione di sbaglio tecnico. Come Aristotele aveva ampiamente mostrato nell’Etica Eudemea (VIII, 1, 1246 a. 26 - b 36) e più stringatamente nell’Etica Nicomachea (VI, 5, 1140 b 22-25), ripreso da san Tommaso in I-II, q. 21, a. 2, ad 2um, nell’ambito del fare è più colpevole chi sbaglia non sapendo di sbagliare che non chi sbaglia sapendo di sbagliare, il contrario invece accade nell’agire. La ragione è data profondamente nel testo tomista: in artificialibus enim ratio ordinatur ad finem particularem, quod est aliquid per rationem excogitatum. In moralibus autem ordinatur ad finem communem totius humanae vitae. Cioè: poiché è la ragione umana che costituisce l’ordine del e nel fare, il valore del fare medesimo dipende dalla ragione, per cui il «peccato» nel fare non si ha quando si è consapevoli di peccare, ma quando si «pecca» inconsapevolmente. Inconsapevolmente, infatti, significa debolezza della ragione, deficienza della ragione nello excogitare finem particularem. Al contrario, avviene nell’agire, poiché non è la ragione ad excogitare finem communem totius vitae humanae: essa non ha alcun potere costitutivo, al riguardo. Ciò che costituisce l’uomo nel rapporto col fine ultimo è l’atto della libertà ed è l’atto della libertà a decidere quale fine ultimo scegliere per la propria esistenza. Onde, il peccato non consiste formalmente nell’errore della scelta, ma nella scelta stessa in quanto si adegua o no al vero fine ultimo. Per cui il peccato è e può essere solo consapevole.
Stringendo in sintesi, possiamo dire: esaminando attentamente il metodo deliberativo dell’utilitarismo sia prima che dopo la deliberazione, giungiamo alla stessa conclusione, che è la seguente. La ragione pratica etica è ragione costituente dell’ordine nell’agire, alla stessa maniera con cui la ragione pratica tecnica è ragione costituente dell’ordine nel fare. Cioè: esiste solo un uso pratico della ragione, quello tecnico.
È vero che non mancano consequenzialisti che hanno affermato un uso pratico trascendentale della ragione, in forza del quale la persona umana verrebbe in possesso, conoscerebbe norme morali assolute e universalmente valide. Quest’ammissione, però, non muta, mi sembra, la conclusione precedente.
In quanto trascendentale (nel senso kantiano), questo uso in realtà non ci fa conoscere nulla (quelle norme sono giudizi puramente analitici, cioè tautologici): esso non ha di fatto — né può avere — alcuna rilevanza noetica per conoscere se l’atto che la persona sta per compiere è giusto o ingiusto. Questo è dato a conoscere solo attraverso l’esperienza che, come tale, non può generare che conoscenze generalmente, non universalmente, valide [nota 19: Comparare il rapporto fra «norme trascendentali» e «norme categoriali» al rapporto istituito da san Tommaso fra norme morali universali e norme morali particolari (praecepta prima-praecepta secundaria), è storicamente infondato. Per Tommaso non è un rapporto fra conoscenze puramente formali, prive di contenuti e conoscenze che hanno un contenuto, ma un rapporto fra implicito-esplicito. All’origine di questa comparazione sta la totale incomprensione (suareziana) di ciò che Tommaso chiama apprehensio entis, che non è quella più carente di determinazione, ma la più ricca e perciò la più bisognosa di essere esplicitata, per mostrare tutta la sua ricchezza. Così, di conseguenza, avviene di ciò che cade per primo nella apprehensio rationis practicae: bonum est faciendum-malum est faciendum].
2. Verso il ristabilimento della distinzione
Fino ad ora abbiamo cercato di descrivere un fatto accaduto nella vita spirituale dell’Occidente, il fatto del passaggio dalla distinzione, all’interno della razionalità pratica, fra ragione etica e ragione tecnica alla riduzione della prima alla seconda, affermando che esiste una sola funzione della ragione pratica, quella tecnica. Correlativamente, la saggezza è ridotta esaustivamente all’abilità tecnica. Non ritengo necessario fermarmi sulla descrizione dei principali epifenomeni che significano questo evento spirituale, perché ne conseguono [nota 20: Faccio qualche accenno. Il problema della giustizia è pensato come problema di una migliore organizzazione sociale. Il problema di una procreazione responsabile è pensato come problema di inventare contraccettivi sempre più efficaci e con effetti collaterali negativi sempre minori. Si pensi anche alla biotecnologia nell’ambito umano]. Ciò che mi interessa è piuttosto tentare un giudizio valutativo del fatto, per sapere se questo evento debba essere accolto come una ricchezza spirituale o piuttosto da respingere come una ricaduta in un essere meno uomini. Sono perfettamente consapevole della difficoltà teoretica di questo momento valutativo; tuttavia, si tratta di un compito di cui ciascuno è responsabile e che non si può più eludere. Ciascuno lo fa coi mezzi di cui è in possesso.
Ciò che balza immediatamente agli occhi dello spirito che considera quella riduzione, è che essa esalta la funzione creativa (produttiva) della ragione (pratica). Se non fosse un linguaggio che potrebbe prestarsi ad equivoci, si potrebbe dire che la direzione della sopraddetta riduzione procede nel senso di un allontanamento dalla concezione della attività razionale come attività-passiva (misurata), verso la concezione dell’attività razionale come attività-attiva (misurante; ci si scusi il bisticcio di parole).
Se ora confrontiamo questo risultato, finora raggiunto dalla nostra riflessione, con un punto di riferimento essenziale nel pensiero cristiano, la metafisica tomasiana dello spirito creato, constatiamo che quel fatto può essere pensato anche come una progressiva negazione della distinzione reale fra intelletto e volontà e della distinzione reale delle facoltà spirituali dall’essenza spirituale.
Si tratta alla fine, allora, di una questione di scuola, che non ha cioè alla fine nessuna importanza decisiva per il destino eterno della persona umana? Poiché l’intelletto è la facoltà del vero e la volontà è la facoltà del bene, siamo cosi condotti al nodo teoretico-esistenziale di ogni vicenda spirituale, il rapporto di verità-bene-libertà. Si tratta, infatti, di un rapporto di cui vive ogni persona umana e che si mostra immediatamente, nel suo significato più ovvio anche se spesso dimenticato, nella nostra coscienza: la libertà come ricerca del bene abita dentro la verità o supposta tale (chi sceglie un bene non ritenuto, cioè non visto come tale?) e inscindibilmente è la libertà che spinge l’uomo alla ricerca, mai terminata, della verità. Ed è dal modo col quale sciogliamo questo nodo, sul piano teoretico ed esistenziale, che dipende il nostro destino eterno. E, dunque, la valutazione che ora mi accingo a proporre, intende muoversi in questo contesto.
2. 1. Se consideriamo un atto libero qualsiasi, possiamo distinguere in esso due dimensioni. In primo luogo è questo atto e non altro, è un atto di amore, non di odio; è un atto di preghiera, non un gioco. L’atto cioè ha la sua specificità che lo differenzia da qualsiasi altro e lo definisce precisamente. In secondo luogo, questo atto è un atto, è cioè il risultato della messa in esecuzione di una nostra facoltà, è il risultato della messa in opera di un nostro dinamismo. La prima considerazione prende in esame l’atto dal punto di vista puramente formale, della sua causa formale, di ciò che fa sì che sia questo atto e non un altro. La seconda considerazione prende in esame l’atto dal punto di vista puramente esecutivo, della sua causa efficiente, di ciò che fa sì che l’atto sia.
Passando ora a una riflessione più esistenziale, vediamo senza fatica che l’esperienza del nostro agire ci attesta che fra le due considerazioni esiste un ordine di priorità-posteriorità. Esiste una priorità della causalità formale nei confronti della causalità efficiente, nel senso che essa è il presupposto necessario perché il dinamismo (la causa efficiente) possa produrre il suo effetto: nessuno semplicemente agisce, ma agisce compiendo questo atto determinato. È il senso primo del noto adagio «nihil volitum quin precognitum». Ma esiste una priorità della causalità efficiente nei confronti della causalità formale, nel senso che nulla è fino a quando la facoltà non è messa in atto: posso pensare, e anche assai profondamente, per tutta la vita anche, di amare una persona, ma finché non la amo, non la amo veramente. Il pensare (di amare) non causa l’essere (di un solo atto di amore), l’amore pensato non è ancora l’amore reale [nota 21: Su questo punto assai importante in questa riflessione si veda S. Kierkegaard, La malattia mortale, cit., 669-672]. Per cui, in assoluto (cioè non considerando più le cose dal punto di vista di una causa o dell’altra) nella vicenda spirituale di ciascun uomo, ciò che è primo è la sua decisione libera, è questa l’atto che dà origine alla nostra storia e continuamente la genera. In questo senso, l’identificazione agostiniana della persona colla volontà (homines sunt voluntates) è ineccepibile. Ma è un punto che deve essere approfondito rigorosamente.
Non esiste alcun atto della persona che sia più intimo alla persona — e dunque che appartenga maggiormente alla persona — dell’atto della volontà. Infatti, tutti gli atti di tutte le altre facoltà umane dipendono nel loro esercizio da un atto di volontà: mangio perché voglio mangiare; vedo perché voglio vedere; comprendo perché voglio comprendere. Al contrario, la volontà dipende nel suo esercizio esclusivamente dalla volontà, voglio perché voglio [nota 22: Cfr Sant'Agostino, De libero arbitrio, I libro per intero]. Ma questa semplice constatazione potrebbe, ancora una volta, imprigionarci dentro un puro formalismo, senza farci cogliere tutta la rilevanza esistenziale dell’atto del volere. San Tommaso ha varie volte insegnato che, da una parte, la passione originaria della volontà è l’amore e che, dall’altra, «amor quo quis diligit seipsum est forma et radix amicitiae» (II-II, q. 25, a. 5), cioè di ogni altro amore. Si notino le due qualificazioni: è forma, è ciò che informa, specifica ogni altro amore; è radix, è ciò che fonda, rende possibile, fa essere ogni altro amore, l’Umgreifende della tendenza della persona verso il bene. In che senso? Nel senso che in ogni atto di volontà è sempre implicato il soggetto che vuole; il soggetto pone se stesso in ordine al bene voluto, in quanto si sotto-intende/sovra-intende sempre come colui che vuole essere nella comunione con Dio, scelto come suo bene sommo, o con un bene creato [nota 23: Ho approfondito questo punto in Living in Christ, Ignatius Press 1987, 131-155. Si veda anche C. Fabro, Presentación all’opera di C. Cardona, Metafisica del bien y del mal, Pamplona 1987, 17-22]. Non si tratta di una identità formale, tautologica e, dunque, immobile di soggetto-oggetto; si tratta di una identità che si realizza nella processione esistenziale da una unità sintetica (non analitica) reale: è, appunto, come dice Tommaso, la radice della nostra storia.
Ma per cogliere ancora più profondamente quest’unità sintetica reale, è necessaria un’ulteriore riflessione. È un dato immediato della nostra coscienza il nostro instancabile peregrinare da un bene all’altro. Solo un’illusione della nostra mente può farci pensare che questo peregrinare non abbia in realtà nessuna meta: non è possibile un movimento senza una direzione. E sulla base di questa semplice constatazione che tutti i grandi maestri dello spirito hanno concluso che la direzione del movimento non poteva essere né questo o quel bene, in quanto «questo» o «quello», ma il bene come tale (bonum in communi). E, dunque, il movimento della volontà ha questa direzione: il bene come tale. Negare l’esistenza di esso (prescindendo ancora dalla sua natura) equivale a negare il proprio esistere stesso. Tuttavia, è ancora la libera volontà che decide della direzione da imprimere a se stessa e, dunque, all’esistenza della persona. Cioè: è la volontà che decide ove porsi, con quale bene identificare il bene come tale; in termini più scolastici: è la volontà che decide quale sia il fine ultimo della persona. Questa identificazione non è pensata semplicemente; è voluta, è posta in essere: precisamente, nell’essere della persona (amor sui, radix et forma) che si attua, si pone nella scelta del suo fine ultimo.
2. 2. Ma questi dati della nostra vicenda spirituale hanno ricevuto due interpretazioni essenzialmente diverse.
A) La prima interpretazione è il tentativo teoretico di giungere ad un completo superamento di quella dualità in cui sembra (quanto meno) realizzarsi la vita della persona. E l’esito è che verità e libertà coincidono o, il che è lo stesso, tutta la vicenda spirituale della persona ha la sua ultima origine dalla libertà: non c’è nulla prima di essa. Ma bisogna procedere con attenzione, passo dopo passo.
Il punto di partenza possiamo vederlo nei paragrafi 15-17 della Critica della Ragion pura. L’Io penso è la possibilità a priori dell’oggettività in generale, «l’unificazione non è negli oggetti e non può essere considerata come qualcosa di attinto ad essi mediante percezione, e per tal via ricevuto primieramente nell’intelletto: essa è unicamente un’operazione dell’intelletto, quest’ultimo, poi, non è altro che la facoltà di unificare a priori e di sottoporre all’unità della appercezione il molteplice delle rappresentazioni date; ed è questa il principio supremo di tutta la conoscenza umana» (§ 16; ed. it. Laterza, Bari 1966, voI. 1° , 134). Nella Dialettica trascendentale, come è noto, Kant ha voluto dimostrare che non è possibile il passaggio dall’Io penso all’affermazione di una sostanza spirituale (soggetto sussistente): questo passaggio si fonda su un equivoco. «L’unità della coscienza che sta a fondamento delle categorie, è presa per l’intuizione del soggetto come oggetto e ad essa è applicata la categoria della sostanza» (ed. cit., 339). Nel già citato par. 16, Kant afferma che l’appercezione pura, originaria, trascendentale «è in ogni coscienza una ed identica». Egli, cioè, ammette l’esistenza di molte coscienze, di molti soggetti nei quali è presente l’appercezione pura (cioè non empirica). È, tuttavia, una ammissione che non è più evidente, ma che dovrebbe essere dimostrata ormai.
Il passo successivo teoreticamente consisterà precisamente in due momenti. Il primo. Poiché l’unificazione di cui si è parlato poc’anzi, non è «attinta» dagli oggetti, ma è opera dell’intelletto che la produce secondo le sue leggi originarie, è la libertà la sorgente dei giudizi intellettivi e, pertanto, di tutta l’esperienza unitaria e sistematicamente ordinata. E una libertà pura, originaria, trascendentale, cioè, che rende possibile tutto [nota 24: È da leggersi su tutta questa problematica C. Fabro, Dialettica della libertà e autonomia della ragione in Fichte, in Riflessioni sulla libertà, Rimini 1983, 133-159. In francese, lo studio è pubblicato in «Revue Thomiste», LXXXVIII, 2 (1980), 216-240]. Si ha l’identificazione di attività spirituale e libertà. Il secondo momento consiste nell’affermazione che verità-libertà sono nel tutto e non nel frammento del singolo uomo.
Mi sembra che la riduzione della ragione etica alla ragione tecnica ha trovato in questa prima interpretazione il suo terreno di cui si è nutrita e da cui è nata, giungendo coerentemente alla sua forma più compiuta e rigorosa [nota 25: Si rende necessaria una precisazione a questo punto. È noto che il sistema utilitaristico nel senso storico ha avuto una sua vicenda storica: è noto altresì che Kant lo combatté teoreticamente vedendo in esso non un errore, ma l’errore per eminenza etico. Il nostro discorso è dunque un «lucus a non lucendo»? Due semplici osservazioni. Non esamino l’utilitarismo come dottrina storicamente chiusa, ma nella sua versione attuale (soprattutto nell’ambito della teologia morale cattolica) consequenzialista. Per questa versione avanzo l’ipotesi che esso commetta 1) l’errore di confondere ragione etica con ragione tecnica, fino ad una progressiva riconduzione della prima alla seconda e 2) che questa confusione-riconduzione si sia teoricamente nutrita dell’antropologia trascendentale. D’altra parte ogni sforzo di chiarificazione comporta una certa semplificazione]. E scopriamo le radici ultime delle aporie insolubili in cui il sistema etico si trova impigliato insolubilmente, di cui abbiamo precedentemente parlato.
E la radice ultima mi sembra la seguente, alla fine. La concezione di una coscienza-autocoscienza creativa umana è la distruzione pura e semplice dell’etica. Se non esiste una verità sul bene e sul male che mostri atti giusti/ingiusti ratione obiecti; se questa verità non è una verità di cui non si possa discutere, ma che semplicemente deve essere accettata o rifiutata; se questa verità non è mai a disposizione della libertà, perché, al contrario, è la libertà che è a disposizione di essa: l’etica, nella sua originaria intenzionalità, o è da ritenersi un’illusione o è da interpretarsi come linguaggio che dice qualcosa d’altro. In ogni caso, essa non è.
B) La seconda interpretazione ritiene che la dualità di cui si parlava sia insuperabile.
La «serietà» dell’atto libero consiste precisamente nel fatto che da esso, non da altro, dipende l’essere o il non-essere della persona nella verità; non consiste nel fatto che da esso dipende la verità dell’essere (della persona). È questo il nucleo essenziale dell’etica, nel quale convergono in tensione reciproca e l’atto della libertà e il giudizio della ragione: una tensione mai risolta.
In questa tensione, ciò che è decisivo è l’atto della libertà, poiché è mediante esso che la persona si realizza: non attraverso il pensiero. Esso non produce nulla di reale. Si può pensare per tutta la vita, e in maniera sempre più profonda, a diventare cristiani: non lo si diventa di uno iota, poiché non esiste che un modo solo di diventarlo, decidere di diventarlo. Il vero «caso serio» della vita non è costituito dalla speculazione, né lo si ritrova in essa: il vero «caso serio» è costituito dalla decisione, poiché è in essa che si ha il passaggio all’essere. Donde deriva alla decisione la sua serietà? dal fatto che da essa dipende non la verità del mio pensare, ma del mio essere. Più precisamente: non il vero dipende dalla mia libertà (è vero ciò che decido sia tale), ma l’essere della mia persona.
Ed è precisamente a questo punto che questo polo della tensione esistenziale (l’atto libero) richiama, sempre esistenzialmente, l’altro polo. Se, infatti, la decisione libera fosse l’inizio e la fine, il tutto della vita spirituale, essa si ridurrebbe a un puro gioco, le cui regole possono sempre essere cambiate. Essa girerebbe su se stessa, all’infinito: poiché il filo non ha alla sua fine il nodo, la cucitura continua senza posa senza cucire. È la decisione che non decide nulla, poiché essa decide solo di decidere. Ora, al contrario, nell’atto libero abita una necessità singolare, abita una legge (lex libertatis) che lo precede e gli è connotata dall’intelligenza: una verità che riguarda precisamente quel «se stesso» che sta per attuarsi nella e mediante la decisione libera.
Consideriamo la persona nel momento in cui sta per decidersi: la persona κατὰ δύναμιν direbbe Kierkegaard (La malattia mortale), la persona posta fra il nulla del non (essere) ancora e l’essere del reale. Essa è dialetticamente posta in una necessità: nella necessità di essere se stessa e in una possibilità: nella possibilità di diventare se stessa. Dialetticamente significa che essa non può allontanarsi dalla necessità tanto da diventare pura possibilità [nota 26: Come avviene quando si nega che esistano atti in sé e per sé (ratione obiecti) illeciti. Negazione che si contestualizza alla fine nella affermazione che è la ragione (cioè, di fatto, la libertà) che fa l’ordine: ragione etica = ragione tecnica] né allontanarsi dalla possibilità tanto da diventare pura necessità.
Questa tensione dialettica può essere conservata solo quando la persona si pone, nella sua decisione, qui e ora, immediatamente in rapporto a Dio [nota 27: La tradizione etica ha precisato con grande rigore teoretico il significato di questo «immediatamente», distinguendo fra l’immediatezza abituale e attuale, esplicita ed implicita]: immediatamente, non mediante le conseguenze del suo atto, non mediante la rilevanza del proprio atto sulla e nella storia.
Israele nasce sulle rive del Mar Rosso. Da una parte c’è l’esercito del Faraone, contro cui combattere è pura follia: è un atto le cui conseguenze sono già prevedibili. Dall’altra parte c’è il mare e l’attraversarlo è follia il solo pensarlo: è un atto le cui conseguenze sono già prevedibili. Non resta che un atto che produca un totale maggiore di felicità, uno solo; un atto che produca un minimo di mali e un massimo di beni: la resa al Faraone. Delle tre possibilità, solo questa per l’Israele che giudica secondo le conseguenze, è quella eticamente percorribile. Questo è l’Israele della pura possibilità, che non ha nessun «se stesso». Ma, Mosè — che ha già visto la Gloria di Dio nel roveto ardente — sa che esiste una quarta possibilità, quella semplicemente di affidarsi al Signore, che è l’unica che fa diventare se stesso Israele. E si noti: non esiste una possibilità più possibile di questa, poiché non ha nessun supporto sulla realtà storica (quando mai si è attraversato a piedi il mare? quando mai si è vinto un esercito cosi agguerrito senza armi né cavalli?); non esiste una necessità più necessaria di questa, poiché è l’unica via per diventare se stessi (le altre due portano all’auto-distruzione). E si noti ancora: non esiste, quindi, una possibilità più necessaria e una necessità più possibile cioè più affidata alla libertà. E Israele è nato perché ha creduto a Dio e al suo servo Mosè; e morirà, perché in seguito spezzerà questa dialettica di necessità e possibilità.
La vicenda spirituale è questa dialettica: romperla significa evacuare l’etica, cioè distruggere la persona.
Le due interpretazioni sono due modi irriconciliabili: non datur tertium. Verità e libertà o sono pensate e vissute coincidenti o sono pensate e vissute dialetticamente [nota 28: L’irriconciliabilità è stata affermata con grande lucidità già da Fichte come è possibile verificare nell’art. cit. (sopra, nota 24) di C. Fabro, ed è il tema di La malattia mortale di S. Kierkegaard].
Conclusione: o Sir Ugo de Morville o Abramo
Alla fine del suo dramma Assassinio nella Cattedrale, T.S. Eliot immagina che i cavalieri, omicidi dell’Arcivescovo, si rivolgano al pubblico per giustificare la loro condotta. Di particolare interesse è la difesa di Sir Ugo de Morville [nota 29: Cfr T.S. Eliot, Opere (a cura di A. Sanesi), Classici Bompiani 1986, 373-374]: è l’esposizione della tesi consequenzialista.
«A nessuno dispiace più che a noi d’essere obbligati a usate violenza. Sfortunatamente vi son tempi nei quali la violenza è l’unico modo per poter assicurare la giustizia sociale. In altri tempi voi condannereste un Arcivescovo con un voto del Parlamento e lo decapitereste con tutte le forme come traditore e nessuno porterebbe la taccia di assassino... Ma, se voi siete ora arrivati a una giusta subordinazione delle pretese della Chiesa al benessere dello Stato, ricordatevi che siamo stati noi a fare iI primo passo».
Ben diversa è l’attitudine di Abramo, anzi contraria. Egli sa semplicemente che per essere se stesso, deve uccidere il figlio, poiché questa obbedienza lo fa diventare ciò che è: il servo del Signore. Dal punto di vista delle conseguenze, era l’unica scelta completamente sbagliata: la sua discendenza sarebbe finita.
Chi ha ragione? «Dal punto di vista della storia universale diventa falsa una proposizione, che dal punto di vista etico è vera ed è la forza vitale dell’etica: il rapporto di possibilità che ogni individualità esistente ha rispetto a Dio» (S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non filosofica, parte seconda, Sezione seconda, Cap. primo, in Opere, ed. cit., 341b). È questa, alla fine, la conclusione. Dal punto di vista della storia (inglese), Ugo de Morville ha ragione e Abramo ha torto; dal punto di vista etico, ragione e torto si rovesciano.
La falsità della proposizione del cavaliere risulta evidente considerando attentamente la sua argomentazione: essa poggia tutta su ciò che avverrà nel futuro ed è in esso e da esso che egli riceve l’assoluzione quando egli sarà già morto. Ma questo modo di argomentare dimentica la cosa più evidente: che una volta Ugo de Morville è stato vivo. Ma questo deve essere dimenticato, altrimenti tutta l’argomentazione crolla interamente, poiché la considerazione storica (consequenzialista) comprende tutto partendo dal dopo che l’atto è già stato compiuto: non è l’uomo κατὰ δύναμιν, nell’istante della sua decisione esistenziale, che interessa. Non è l’uomo reale, vivo, ma l’uomo già passato. Tutto al contrario accade nell’argomentazione etica che sostiene Abramo: egli è giustificato per la sua fede, cioè per il modo con cui pone se stesso ora e qui di fronte a Dio.
E l’etica è la verità dell’uomo perché Dio non è il Dio dei morti, ma il Dio dei viventi; e la suprema decisione cui è chiamata oggi la libertà dell’uomo è se considerare se stesso dal punto di vista delle conseguenze storiche del suo agire o dal punto di vista dell’eternità.
|