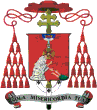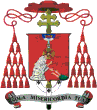Il valore della norma nella storia della salvezza
Firenze, 9 giugno 1992
La complessità e la difficoltà del tema è dovuta a molte cause. Non ultima è l’ampiezza di significato che nella tradizione etica occidentale ha assunto il termine di norma o legge. Se poi riflettiamo sul tema del valore della norma o legge in un contesto teologico, come la formulazione invita a fare, la complessità e difficoltà aumentano. È noto, infatti, che la domanda sul valore della norma ha accompagnato costantemente la coscienza cristiana fin dall’inizio, e non ha ricevuto sempre la stessa risposta. Anzi, anche risposte così diverse da causare profonde divisioni nel corpo della Chiesa.
Questa elementare constatazione mi costringe a delimitare rigorosamente l’ambito della mia riflessione e la sua precisa prospettiva: l’oggetto materiale e l’oggetto formale, direbbe la logica. E comincio dal secondo, cioè dall’oggetto formale. Affronterò il tema del valore della legge nella storia della salvezza dal punto di vista proprio della teologia morale, cioè dal punto di vista dell’atto della persona. È questo infatti che “interessa” scientificamente alla teologia morale: la persona nel suo attuarsi liberamente attraverso i propri atti, o meglio, poiché trattasi di teologia morale, la persona vivente in Cristo.
Tenendo conto di questa prima ed essenziale determinazione, il tema acquista immediatamente un contenuto assai preciso: quale valore ha la legge morale per la persona credente, in quanto soggetto che si attua liberamente nei e attraverso i suoi atti? Quale è il valore della legge morale per la persona nel momento in cui realizza il suo essere in Cristo attraverso il suo agire libero? È a questa domanda che cercherò di rispondere, non ad altre possibili (e sarebbero molte).
Ancora, e infine, un’altra premessa. Avrete notato che ho aggiunto “morale” al termine “legge”. È di questa legge o norma che intendo parlare, anche se alla fine della mia riflessione, non mancherà una breve riflessione anche alla legge civile.
1. Sic et non: il problema
Partiamo da una constatazione molto semplice, ma assai importante, sulla quale non c’è discussione, trattandosi di un fatto abbastanza evidente. Alla nostra domanda il Nuovo Testamento non sembra offrire una risposta univoca, ma sembra offrire una duplice serie di affermazioni non armoniche. E ciò non è vero solo nel Nuovo Testamento nel suo insieme, ma anche all’interno dello stesso autore.
Il caso di san Paolo al riguardo è assai emblematico. È certo, senza alcuna ambiguità, che una delle conseguenze fondamentali dell’atto redentivo di Cristo è stata la liberazione dalla legge: anzi questa “caduta” o estromissione della figura della legge dalla coscienza del neofita è “articulus stantis vel cadentis existentiae christianae”, il cristiano non è più sotto la legge. E si noti che il termine legge non connota solo quell’insieme di usi, consuetudini, norme che noi oggi diremmo positive, ma precisamente ciò che noi oggi denotiamo col termine legge morale.
Ma non è meno certo che sul piano del comportamento, san Paolo dà norme molto precise ai suoi cristiani e ne esige la più stretta osservanza. Non solo, ma soprattutto egli condanna con parole terribili quei cristiani che intendono la liberazione dalla legge come fosse al cristiano tutto permesso: li giudica peggiori dei pagani.
La Tradizione della Chiesa sembra non aiutarci molto, a prima vista, ad uscire da questo “sic et non” biblico. Infatti essa trasmette con grande forza e testimonia questa verità della libertà cristiana dalla legge: basti pensare alle mirabili pagine di sant’Agostino contro Pelagio o agli articoli della Somma Teologica sulla “lex nova”. Tuttavia, nella stessa Chiesa il Decalogo è stato uno dei momenti centrali del suo impegno educativo dei nuovi cristiani.
La catechesi cristiana si è costruita attorno al Simbolo della fede, ai Comandamenti, alla Preghiera del Signore.
Questo fatto ci dà subito un insegnamento che, dal punto di vista metodologico, è di importanza decisiva per chiunque intenda affrontare questo problema: questo è un problema di analogia della fede. Mi spiego. Si tratta di avere un’intelligenza di ogni singolo dato tale che ci permetta di armonizzarlo con ogni altro, senza escludere nessuno. È l’intelligenza dell’armonia di una verità che è sinfonica e non melodica.
La storia del pensiero cristiano ha dimostrato che quando si è dimenticato questo, il problema ha sempre ricevuto una risposta sbagliata, perché era una risposta che disarticolava l’unità profonda del Dato rivelato. Del resto san Paolo ci indica chiaramente che questa è la direzione da prendere, quando opera quell’identificazione con l’espressione “lex Spiritus”, la legge che è lo Spirito, dove i due termini non sono il polo positivo e il polo negativo della corrente, che toccandosi si bruciano. Ciascuno rimane nella sua identità proprio nell’unità, così che separandosi, quell’identità è perduta. È questa la strada che dovremo percorrere.
2. L’esperienza pratica umana
Da dove cominciare questo percorso? È logico iniziarlo non da ciò che è meno alla portata della nostra conoscenza, ma da ciò che noi possiamo più facilmente conoscere: la nostra esperienza pratica. Per “esperienza pratica” intendo molto semplicemente l’agire della persona, visto nella sua origine ultima, cioè in quanto causato dalla nostra volontà.
Dunque, brevemente: per “esperienza pratica” intendo l’agire della persona in quanto agire volontario. La sua descrizione occuperà completamente questo secondo punto della nostra riflessione.
Cominceremo a individuarne la specifica natura, separandolo da ogni altro agire che può verificarsi nella nostra persona senza essere, in senso interamente vero, della nostra persona. Se è facile distinguere nettamente l’agire volontario dall’agire semplicemente causato in noi da una violenza esteriore, non è facile distinguere nettamente l’agire volontario dall’agire spontaneo. Eppure, la mancata percezione di questa chiara distinzione è causa di gravi confusioni ed errori proprio nel nostro ambito di riflessione, come vedremo. Cerchiamo quindi di mostrare questa distinzione.
È vero che l’agire volontario/libero e l’agire spontaneo hanno un comune denominatore: di avere la loro origine nella persona e dalla persona, separandosi già in questo dalla violenza subita. Ma si tratta di una similitudine generica che nasconde in sé una differenza specifica. L’agire volontario/libero ha origine nella e dalla persona in un modo specificamente diverso dall’agire spontaneo. In che cosa consiste questa differenza specifica? Se facciamo attenzione a noi stessi, non è cosi difficile rispondere a questa domanda.
L’agire volontario/libero presuppone (si noti bene: presuppone, non consiste in) la progettazione razionale del possibile corso di azione, nel senso che la ragione intra-vede in esso (possibile corso di azione) una bontà, lo presenta alla volontà sotto questa luce (in quanto dotato di una bontà) così che se questa, se si muove verso di esso (se lo vuole), lo fa proprio e precisamente in ragione della bontà. Questa prima, essenziale differenza specifica (l’altra la vedremo fra poco) del movimento volontario/libero ha ricevuto un nome tecnico nella antropologia filosofica: il movimento volontario/libero è un movimento intenzionale.
La comprensione dell’intenzionalità del movimento libero è di decisiva importanza per tutta la nostra questione. In linea generale possiamo dire subito che qui intenzionalità significa “conoscenza formale del fine”, cioè: la persona conosce espressamente ciò in vista di cui compie l’azione, come obiettivo del suo agire, valutandone la convenienza come tale. È un tendere giudicando, un giudicare tendendo. È un atto, quindi, cosciente; non solo nel senso limitato di un atto “di cui ho coscienza”. Posso aver coscienza anche della mia attività respiratoria, ma non per questo essa diventa un’attività cosciente, poiché non implica nel suo intimo, intrinseco essere un’attività razionale.
Ma questo non è tutto. L’intenzionalità della volontà è attiva: è la persona che muove se stessa verso quell’oggetto. Troviamo qui la seconda differenza specifica dell’agire volontario/libero nei confronti dell’agire spontaneo: l’auto-determinazione. È la più profonda e la più misteriosa. È la persona che posta di fronte al progetto elaborato dalla ragione, al possibile corso di azione, può muoversi verso esso; può (direbbe forse Agostino) spirare da sé un atto di amore verso quel bene che la ragione ha intravisto nel possibile corso di azione. In una parola: può volere quell’azione precisamente a causa di quella bontà che la ragione ha intravisto in essa. Dunque: il movimento volontario/libero si distingue dal movimento spontaneo perché è un movimento intenzionale e di auto-determinazione. Dobbiamo ora fare una riflessione assai importante riguardante il rapporto fra queste due proprietà specifiche del movimento volontario/libero.
L’oggetto intenzionale, cioè il possibile corso di azione a cui la volontà si dirige intenzionalmente, è conosciuto e valutato dalla ragione: è una conoscenza valutativa, cioè una conoscenza riguardante la bontà propria di quell’azione. Ed è per questo che diviene “motiva”, cioè muovente la volontà (meglio: la persona). Tuttavia, e la nostra esperienza interiore ce lo testimonia, il giudizio valutativo della ragione non costringe la persona nel senso che essa non possa non consentire, compiere quell’azione. L’agire libero non consiste nel giudizio valutativo della ragione; è altro da esso. Di che natura è , allora, questa motivazione, attrazione che la ragione esercita nei confronti della nostra libertà? O, in che cosa consiste questa motivazione?
La risposta è la seguente: è il dovere. La ragione ha un solo modo di muovere la volontà, quello di dirgli: “devi compiere quest’azione”. Ma che cosa è precisamente questa intimazione? questa motivazione insita nell’esperienza che noi viviamo e che noi descriviamo dicendo: “posso, devo, ma posso non… perché non sono coatto”.
Si noti subito che l’intimazione razionale, il dovere, implica una visione, un giudizio mediante il quale la persona intra-vede nel possibile corso di azione una bontà tale che rende quell’azione non semplicemente possibile, operabile, ma degna di essere voluta, di essere operata. Ha cioè in se stessa una tale preziosità, appunto una tale bontà, da esigere di essere amata dalla volontà, o, se al contrario, odiata dalla volontà, il dovere cioè è la sintonia fra il bene conosciuto della ragione e la persona in quanto soggetto capace di atti volontari/liberi.
Descrivendo ancora con attenzione l’attività della ragione, possiamo vedere che essa si esercita a un duplice livello. Il primo, quello più immediato (e più decisivo) per la nostra esperienza pratica, consiste in quell’intimazione pratica, in quel giudizio prescrittivo che è sempre implicato in ogni nostra scelta: fai questo/non fare questo. È chiamato giudizio di scelta o, reciprocamente, scelta giudicante. Ma l’attività della nostra ragione non si esaurisce in questo. Questo giudizio di scelta è il risultato di una riflessione razionale su ciò che è bene, su ciò che è male (su ciò che è dovuto da una volontà razionale) non solo nel mio caso, in queste circostanze, ma in universale.
“Non fare questo, perché questo è un furto”: si ha qui l’incontro di un sapere razionale universalmente valido (il furto non deve essere compiuto) con una percezione del particolare (questo è un furto). I giudizi universalmente validi, mediante i quali la persona conosce ciò che la volontà deve amare o deve odiare, sono le norme o le leggi morali. Esse, dunque, sono giudizi della ragione. E come mediante il giudizio della ragione conosco la realtà, così mediante questi giudizi conosco la bontà/malizia di un atto della persona, in quanto possibile oggetto della volontà. Non di questo atto di questa persona in queste circostanze: ma dell’atto considerato in quanto possibile oggetto di una volontà razionale come tale.
Penso che questa descrizione dell’esperienza pratica sia sufficiente per il nostro scopo. La riassumo.
L’atto della persona, l’atto nel quale e mediante il quale la persona si realizza, è un movimento intenzionale che nasce dall’auto-determinazione della persona, in ragione della dignità insita nell’atto possibile, in forza della quale, esso (atto possibile) deve essere amato dalla volontà e il suo contrario deve essere odiato e mai realizzato.
Prima di procedere oltre vorrei ora, alleggerendo un poco il discorso, fare alcune precisazioni terminologiche, rese possibili dalla descrizione appena compiuta e molto importanti per il seguito della nostra riflessione.
• Esiste una distinzione concettuale fra legge morale e dovere. Il dovere esprime la reciproca, originaria appartenenza del bene morale e della volontà razionale. La legge morale è un giudizio razionale mediante il quale la persona conosce precisamente ciò che è appropriato a una volontà razionale. Quindi: il “dovuto” non è tale perché è “legale”, ma viceversa, il “legale” è tale perché è “dovuto”, il dovere è ciò che fa essere la legge morale, la legge morale è ciò che fa conoscere il dovere.
• Una seconda e più importante precisazione. Agire per dovere non solo non si contrappone ad agire liberamente, ma al contrario è la più perfetta espressione della libertà. Si contrappone ad agire spontaneo. L’agire spontaneo è l’agire secondo le proprie inclinazioni in quanto orientate verso i propri fini naturali; l’agire per dovere è agire secondo le proprie inclinazioni in quanto orientate, mediante l’ordinazione razionale, ai fini propriamente umani: orientamento che è costituito dalla virtù. Che questo modo di agire sia il modo più perfettamente libero è dovuto al fatto che la persona, la sua volontà non si trova in uno stato di originaria neutralità o indifferenza sia verso il bene morale sia verso il male morale. Essa è originariamente orientata al bene morale: agire per esso (il che è lo stesso che dire: agire per dovere) è agire secondo l’inclinazione della volontà, cioè liberamente. Fare il male è fare violenza alla volontà, renderla schiava.
• Infine una terza e pure importante precisazione. Non ho mai parlato di obbligazione. Dobbiamo ora brevemente precisare questo concetto, in se stesso e nei confronti degli altri concetti. Il concetto di obbligazione connota sempre un rapporto gerarchico di una persona inferiore nel senso che dirò subito, nei confronti di un altro, superiore nel senso che dirò subito. L’obbligazione è infatti costituita dall’atto con cui una volontà dominante applica una regola d’azione alla volontà di un esecutore subordinato. La superiorità consiste precisamente nella potestà di compiere quest’applicazione e l’inferiorità consiste nel recepirla. È questo rapporto l’essenza dell’obbligazione. Pertanto, nei confronti del bene morale la persona deve aderire liberamente; nei confronti del superiore la persona è obbligata per il fatto che gli è stata notificata una regola di condotta.
Portiamo la nostra attenzione sul divino Legislatore, supponendo già dimostrato che il Creatore è precisamente colui che istituisce la legge morale.
Come egli istituisce la legge morale? Mediante la partecipazione alla legge eterna, all’ordine della Sua Sapienza, al modo di una legge naturale della ragione umana. Materialmente quindi dovere e obbligazione coincidono, ma concettualmente sono distinti: il dovere, per sé, non obbliga, in quanto esso esprime come tale un rapporto di reciproca appartenenza della volontà morale e del bene morale. In questo senso san Tommaso dice che il peccato è la distruzione di un bene umano.
Penso che queste precisazioni siano sufficienti per poter continuare la nostra riflessione.
3. L’aporia dell’esistenza: false soluzioni
La descrizione dell’esperienza pratica che abbiamo fatto nel numero precedente probabilmente ha suscitato in noi una serie di reazioni strane che potremmo descrivere sinteticamente in questo modo: “dovrebbe essere così, ma di fatto…”. La cosa merita molta attenzione. Da una parte noi sentiamo che questa è la nostra verità di persone. Esiste una testimonianza dentro di noi che testimonia la reciproca appartenenza della nostra persona alla verità, alla bontà, alla bellezza e della verità, della bontà, della bellezza alla nostra persona. Ma nello stesso tempo e con la stessa certezza noi sentiamo che questo rapporto di reciproca appartenenza si è spezzato: sentiamo come “violenza” fare il bene e “spontaneo” fare il male. “Desideriamo la verità e in noi non troviamo che incertezza. Ricerchiamo la felicità e non troviamo che miseria e morte. Siamo incapaci di non desiderare la verità e la felicità, e non siamo capaci né di certezza né di felicità. Questo desiderio ci è lasciato, tanto per punirci quanto per farci sentire da dove siamo caduti” (B. Pascal).
Quest’aporia che abita non dentro il nostro pensiero, ma dentro alla nostra esistenza, esige di essere risolta. E non per caso, il valore che si attribuisce alla legge morale dipende strettamente dalla soluzione che si è data a quell’aporia. Vorrei fermare la mia attenzione su tre soluzioni, poiché mi sembrano quelle fondamentali.
3, 1.
Il punto di partenza della prima soluzione è la negazione della reciproca, originaria appartenenza della persona, mediante la sua volontà, alla verità, alla bontà e alla bellezza. La volontà è originariamente indifferente, per sua natura, cioè neutrale sia nei confronti del bene che del male. È questa la definizione formale di libertà: libertas indifferentiae. La libertà è indifferenza. Di conseguenza, l’unico legame che la persona può avere verso il bene è l’obbligazione, nel senso stretto che sopra abbiamo detto. Il bene è l’obbligatorio, nel senso di richiesto da una legge. La bontà morale è ricondotta esaustivamente alla giustizia.
In questa prospettiva è evidente che la legge morale, la sua intimazione, costituisce il momento più importante per la persona umana che cerca, nel suo agire, di raggiungere la pienezza della sua beatitudine. È essa che inclina la volontà al bene. Tuttavia, con uno sviluppo coerente, nello stesso tempo questa importanza è stata circoscritta a un territorio della vita umana ben preciso.
L’affermazione dell’indifferenza della persona nei confronti del bene impedisce di pronunciare un giudizio di verità sul progetto esistenziale in cui la persona cerca di realizzarsi col suo agire. Mi spiego brevemente. Non è difficile constatare che ogni persona umana, che l’esistenza di ogni persona umana non è solitamente un discorso senza costrutto e senza un significato. Solitamente le singole azioni, le proprie scelte piccole o grandi, si inscrivono in un progetto di vita che ha una sua più o meno o grande unità. Ora è possibile chiedersi, ha un senso domandarsi: quale progetto è vero? quale progetto è falso? chiedersi cioè quale è la vera beatitudine. Oppure la domanda stessa è priva di senso, come se si chiedesse: di che colore e la musica di Mozart? Una tale domanda ha senso se e solo se esistono originari orientamenti della persona come tale, realizzando i quali la persona realizza se stessa; non ha nessun senso se tali orientamenti non esistono oppure non hanno una propria consistenza assiologica: se, appunto, la persona come tale è indifferente verso ogni progetto e il contrario di ogni progetto; se la nostra è originariamente libertas indifferentiae. In questo caso ciascuno progetta la propria esistenza: essere beati significa sentirsi beati. In questo territorio dell’umano, non esiste legge ne morale né civile, perché non può esistere.
Resta tuttavia la necessità, data la natura socievole dell’uomo, di organizzare il sociale, dati i molteplici contrari progetti di vita dei singoli e delle comunità: è questo il compito della norma. In questo senso, dicevo che questa visione finisce col ridurre la moralità alla giustizia, col rischio del formalismo.
Questa visione, oggi dominante, è abitata da una difficoltà teoretica che all’interno delle sue posizioni di fondo rimane insolubile. È la difficoltà precisamente di giustificare la legge morale così intesa e la sua osservanza: perché essere morali? perché osservare queste leggi? La questione decisiva emerge proprio quando gli spazi di libertà sono stati assicurati: e di questa libertà che mi e assicurata che ne faccio? Non si può rispondere: tutto ciò che ne fai e il contrario di tutto è ugualmente buono, purché tu lo senta tale. Equivale a rispondere: fanne un uso libero. Il che è semplicemente una risposta che si limita a ripetere la domanda.
L’etica moderna, nella sua (pseudo-) esaltazione del ruolo della norma morale, ha finito col dimenticare il soggetto che agisce.
3, 2.
Pascal terminava la sua riflessione dicendo che il desiderio inestinguibile di verità e di felicità, che ciascuno di noi porta nel suo cuore, ci è rimasto “tanto per punirci quanto per farci sentire da dove siamo caduti”. Questa meditazione pascaliana può costituire il punto di partenza per capire la seconda soluzione all’aporia esistenziale.
Quando uno riceve una ferita molto profonda che si infetta e va a farsi medicare, normalmente il medico fa in modo che la ferita non si chiuda immediatamente. Anzi per impedire che ciò accada, vi mette dentro una garza. La persona non è in uno stato di originaria indifferenza verso il bene e verso il male morale. Essa è radicalmente orientata al male e non può non agire ingiustamente. Che senso ha allora la legge morale? Non certamente quello di inclinarlo a fare il bene: nei confronti di un uomo così radicalmente ingiusto, essa è impotente del tutto. La sua importanza, anzi la sua necessità consiste in un’altra funzione: quella di denunciare continuamente l’uomo, quello di impedire che l’uomo dimentichi che tutto ciò che opera è male, di non consentire mai all’uomo di ritenersi giusto. È appunto lo stesso ruolo della garza nella ferita: impedire che si rimargini.
E quando la ferita fosse rimarginata, quando cioè fosse giustificato, la legge morale perde ogni importanza? In un certo senso certamente: essa perde ogni importanza; in un altro senso, essa conserva la sua importanza.
È entrata anche nella teologia morale cattolica una dottrina dell’agire virtuoso che può essere chiamata la “morale della spontaneità”. Essa afferma che il soggetto virtuoso, giustificato, produce le sue azioni buone non per dovere, ma mosso solamente dallo slancio spontaneo dell’amore per il bene. L’agire della persona è concepito in termini di mera spontaneità, il pullulare spontaneo delle singole azioni da uno stato fondamentale dal quale sono qualificate. In questa visione, la legge morale diventa semplicemente inutile: impotente per l’uomo non giustificato, inutile per l’uomo giustificato. Anzi, il richiamo alla legge morale, al dovere, diventa dannoso, o può diventare dannoso in quanto può distogliere la persona da quella movenza spontanea che caratterizza l’agire del cristiano.
(In una visione protestante classica, luterana, la legge mantiene la sua importanza, perché l’uomo in realtà è simul justus et peccator).
Questa concezione che giunge a espellere dal discorso etico il concetto stesso di legge morale, perché ne espelle il concetto di dovere, in nome di una supposta libertà-spontaneità, non corrisponde né alla natura del bene morale né alla natura della volontà umana.
La libertà di cui gode la volontà umana, quando vuole il bene, non è solo spontaneità. Il bene morale, infatti, esercita una profonda attrazione sulla volontà (retta), ma non è mai un’attrazione necessitante. Esso può essere voluto solo mediante libera auto-determinazione, cioè mediante la deliberazione razionale o il discernimento razionale. Come vedremo subito dopo, la giustificazione rende il giustificato tempio dello Spirito che lo spinge intimamente al bene. Questa presenza, tuttavia, e questa mozione non distruggono il modo umano di volere il bene, anche se lo elevano; la persona vuole il bene morale con libera auto-determinazione, secondo la regola della ragione.
La condizione di libertà perfetta, che ci è donata in Cristo, non può essere intesa come se si trattasse di semplice spontaneità, cioè di necessità interiore della volontà. Questo è il modo istintivo di muoversi verso il bene e non ha nulla di specificamente umano. Si tratta di libertà di auto-determinazione mediante la quale la persona si muove verso il bene, non mossa da un desiderio spontaneo, ma attraverso la scelta giusta che implica sempre un giudizio.
È questa la ragione per cui la categoria di legge morale non può essere espulsa dall’etica cristiana, senza sognare una visione della persona umana che non è quella reale.
Ma tutto questo spero risulterà evidente dalla riflessione immediatamente seguente nella quale cercherò di esporre quella che mi sembra la soluzione giusta all’aporia esistenziale di cui ho parlato.
4. La soluzione vera
Limitiamoci a considerare il cristiano che vive nella giustizia della grazia, nel quale dimora lo Spirito che lo illumina e lo guida. E rifacciamoci la domanda fondamentale: per questa persona, considerata nel momento del suo attuarsi nel e mediante il suo agire libero, quale valore ha la legge morale? Essa non è semplicemente sostituita dallo Spirito?
In una grande pagina, san Tommaso afferma con verità che non agisce liberamente chi fa il bene semplicemente a causa della legge che lo obbliga. E ciò per la ragione, sulla quale nelle pagine precedenti abbiamo lungamente riflettuto, che agire liberamente significa agire auto-determinandosi. Agire, cioè, che implica la conoscenza formale del fine: compio il bene che compio semplicemente e precisamente perché è bene. In questo senso, sant’Anselmo d’Aosta ha definito la libertà come la capacità di conservare la rettitudine per amore della rettitudine stessa. Certamente, chi fa la volontà di Dio, agisce senz’altro con giustizia. Ma ciò che Dio vuole è, appunto, che il rispetto del suo volere non sia né estrinseco né interessato, bensì dovuto al riconoscimento intimo dell’ordine della divina Sapienza, che la Volontà di Dio custodisce. In questo sta il nostro essere immagine di Dio.
Che cosa opera lo Spirito Santo donato al credente? Egli precisamente infonde nella volontà del credente l’amore del Vero, del Bene, del Bello, l’amore di Dio, semplicemente perché è Dio: è la Verità, la Bontà, la Bellezza. San Bernardo esprime in modo mirabile questa esperienza che il giustificato vive, quando scrive: “moveri et affici ad bonum necesse est ab eo utique Spiritu qui adiuvat infirmitatem nostram et per quem in cordibus nostris diffunditur charitas, quae est bona voluntas” (Sermo 1 in die Pentecostes, n. 5). È questa affezione al bene che lo Spirito produce nel giustificato. In questo contesto, la legge morale perde ogni importanza e san Paolo scriverà che non siamo più sotto la legge. Ma in un senso molto preciso: la legge non è più la ragione per cui facciamo il bene ed evitiamo il male. In questo preciso senso siamo liberati dalla legge: il giusto fa ciò che deve facendo ciò che vuole. E non: fa ciò che deve facendo ciò che la legge vuole (perché fa ciò che la legge vuole). Si ha qui la sintesi, non solo pensata ma vissuta, fra libertà e necessità. È una necessità che implica la libertà e dimora dentro la libertà; è una libertà che implica la necessità e dimora dentro la necessità. Quel rapporto di reciproca appartenenza fra volontà razionale e bene morale, di cui ho parlato descrivendo l’esperienza pratica e che costituisce la santità originaria dell’uomo, è ricostituito dalla presenza dello Spirito nel cuore dei credenti. Ma proprio perché questa è la situazione del giustificato, proprio perché (e non “nonostante che”) egli è liberato dalla legge nel senso preciso suddetto, questa conserva una sua funzione, un suo ruolo. Ed è in questo l’errore della morale della spontaneità di cui parlavo: nel non avere affermato questo.
La mediazione fra la volontà e il bene è operata dalla ragione, come abbiamo già detto varie volte: non esiste atto libero che non sia radicato in un atto della ragione. “Radix totius libertatis judicium rationis”, scrive san Tommaso. Senza attività razionale si ha attività spontanea, non attività libera. Infatti l’attività dello Spirito nel giustificato non si riduce alla trasformazione della nostra volontà, ma essa è anche, e prima, illuminazione della nostra ragione. Lo stesso san Bernardo, nel già citato discorso, dice: “Multi siquidem monentur, ut benefaciant; sed minime sciunt quid agendum sit, nisi adsit denuo gratia Spiritus, et quam inspirat cogitationem, doceat in opus proferre”. Ora, la legge morale è precisamente quel giudizio della ragione, mediante il quale la persona conosce ciò che è universalmente/generalmente bene e, per contrarium ciò che è male moralmente. In questo senso, si può e si deve dire che la legge morale è opera della ragione. A questo punto, dunque, la domanda si fa precisa: l’attività illuminatrice dello Spirito rende inutile, evacua la conoscenza razionalmente raggiunta, cioè la legge morale? E, quindi (la conseguenza sarebbe logicamente necessaria), il Magistero morale della Chiesa diventa inutile?
Prima di elaborare una risposta a questa domanda, è necessario richiamare una grande verità difesa soprattutto da san Tommaso e che costituisce uno dei tratti caratteristici delle visione cattolica: la grandezza di Dio non consiste nel rendere inutile l’attività della creatura, ma nel renderla possibile. La causalità della Causa prima si glorifica non sulle ceneri della causalità delle cause seconde, ma sulla loro esaltazione. La luce dello Spirito non evacua la conoscenza morale razionalmente raggiunta (la legge morale), perché semplicemente la rende possibile in tutta la sua pienezza di verità. Egli ci fa conoscere il bene rendendoci conoscenti in atto del bene. Egli è luce che illumina perché accende la nostra luce.
In questo contesto comprendiamo la necessità, non solo l’utilità, del Magistero morale della Chiesa, cioè di un insegnamento autorevole della legge morale. Per una serie di ragioni che in questo contesto spero risulteranno convincenti.
La prima ragione è che il credente è chiamato a vivere in Cristo: in una “forma” di vita cioè che è meta-razionale. La Rivelazione non è solo creduta, deve essere vissuta. La testimonianza, la luce e la guida interiore dello Spirito, è difesa e custodita contro il permanente rischio di confonderla con altre testimonianze, dalla testimonianza apostolica che si perpetua nella successione apostolica. La testimonianza apostolica al cammino in Cristo aiuta il credente ad accogliere la luce dello Spirito.
La seconda ragione è che la ragione umana, sia pure guarita dalla grazia, resta profondamente indebolita anche in ordine alla conoscenza dei beni propri delle virtù morali. Non solo, ma ciascuno di noi si trova a vivere in situazione di conflitto interiore fra ciò che piace, ciò che è utile e ciò che è bene. Il risultato è l’incertezza sul bene e sul male e non raramente l’errore. Se, da una parte, la luce dello Spirito può illuminare il nostro spirito solo se ci immettiamo in un cammino di profonda ascesi, dall’altra la testimonianza apostolica è aiuto voluto dalla Provvidenza per un uomo che è incerto ed esposto all’errore anche in verità morali puramente razionali.
Riassumo brevemente. Proprio perché lo Spirito libera il giustificato dalla legge, questi (il giustificato) necessità di una profonda conoscenza interiore del bene come tale. Ma questa conoscenza interiore è precisamente ciò che chiamiamo legge morale. Quindi, il giustificato necessita della legge morale: essa è opera della sua ragione elevata dai doni dello Spirito e istruita dal Magistero morale della Chiesa.
Abbiamo quindi visto in che senso la legge morale perde ogni valore, in che senso conserva una sua necessaria funzione. Ora, brevemente, per terminare, vediamo come essa sia insufficiente.
La legge morale può essere negativa o positiva. Ovviamente non possiamo dirigere la nostra vita mediante le norme negative: non si fa il bene non facendo il male, ma semplicemente facendo il bene. Tuttavia, anche le norme positive sono radicalmente insufficienti a dirigere la nostra vita. Questa insufficienza mi sembra che sia duplice.
Si tratta, in primo luogo, di una insufficienza che potremo chiamare logica. Le norme sono proposizioni universali e proprio per questo non sono sufficienti a determinare adeguatamente l’azione concreta da compiersi nelle circostanze della vita sempre variabili. È necessario un tipo di conoscenza che raggiungo non mediante le norme (giudizi universali), ma mediante il giudizio prudenziale, quel giudizio particolare che è sempre implicato nelle nostre scelte. La guida con cui il Magistero morale della Chiesa orienta i credenti è necessaria, ma non è sufficiente. Esiste una guida dello Spirito che sfugge a ogni generalizzazione. E la Tradizione etica della Chiesa è andata elaborando tutta una serie di regole “per il discernimento dello Spirito”.
Ma esiste anche un’altra insufficienza che potremmo chiamare pratica. È questo un punto molto delicato: è stato san Tommaso il primo a richiamare l’attenzione su esso.
Egli parte da una domanda: a quali condizioni è possibile che sia moralmente corretto il giudizio pratico ultimo, il giudizio di scelta, quel giudizio effettivamente adottato dal soggetto nella sua scelta ed effettivamente direttivo della stessa? Non è certo sufficiente il giudizio della coscienza pur essendo particolare: esso, infatti, come ci dice la nostra esperienza, può essere trascurato nel momento della scelta. E quando è trascurato? quando questa conoscenza non esprime i desideri del soggetto agente, le sue intenzioni esistenziali: il principio della scelta effettiva sono i desideri attuali del soggetto. Ora, chi rettifica le inclinazioni umane? non le leggi, ma le virtù.
Concludiamo questo quarto punto. La domanda era: per la persona giustificata dalla grazia di Cristo e abitata dallo Spirito, considerata in quanto soggetto che si attua nel e mediante il suo agire libero, quale valore ha la legge morale? Abbiamo risposto in tre momenti: in quanto principio motivo della scelta, non ha nessun valore, in quanto il cristiano è obbligato solo dal bene; in quanto medio attraverso cui conosco il bene, essa permane necessaria; in quanto principio direttivo ultimo nelle mie scelte, essa è insufficiente.
Conclusioni
Vorrei ora formulare alcune conclusioni generali, molto schematicamente.
Due sono i rischi in cui può incorrere la predicazione morale nella Chiesa: quello della riduzione dell’annuncio cristiano alla dottrina morale oppure quello del silenzio completo. Nel secondo caso si annuncia un Vangelo senza morale, nel primo una morale senza Vangelo. Come spesso avviene nelle vicende spirituali, i due estremi si toccano nella loro radice comune: la convinzione che la fede non ha nulla a che fare coll’esistenza umana, che essa non possa assumere carne umana. E allora ci si rifugia in uno pseudo spiritualismo spontaneistico oppure si pensa che compito principale della Chiesa debba essere di sostenere la creazione di un codice morale comune. La ricostruzione di un corretto rapporto Vangelo-morale è compito urgente.
Questa ricostruzione non è tuttavia opera di pensiero, principalmente. È opera educativa: la creazione di quelle comunità in cui si apprende la “via del Signore” perché si è incontrato il Signore stesso e si è ricevuto il suo Spirito.
|