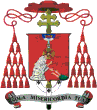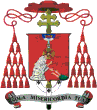Al servizio della verità sul matrimonio
Editoriale della Rivista Anthropos, Anno 1 n. 1, maggio 1985
Nel momento in cui il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia inizia la pubblicazione della sua Rivista ufficiale, non è inutile dichiarare le nostre intenzioni.
La rivista che ora nasce è l’organo ufficiale dell’Istituto e ne è l’espressione. Voluto personalmente dal Santo Padre Giovanni Paolo II, esso, come è detto nella Costituzione apostolica Magnum matrimonii sacramentum che apre il presente numero, è stato fondato «ut veritas Matrimonii et Familiae magis magisque methodo scientifica exploretur».
«Veritas Matrimonii et Familiae»: siamo immediatamente richiamati alla esistenza di una verità, di una identità del matrimonio e della famiglia, che permane nel mutare dei costumi e delle culture. Quella verità da cui sgorgano criteri, permanenti ed immutabili come la loro sorgente, mediante i quali è possibile e doveroso dare un giudizio etico sulle concrete, storiche realizzazioni della comunità coniugale e familiare. Né per individuare e capire questa verità e i criteri del giudizio etico, che da essa promanano, si deve fare attenzione al «consenso sociale». Come è scritto profondamente nella Esortazione apostolica Familiaris consortio, «la Chiesa, seguendo Cristo, cerca la verità, che non sempre coincide con l’opinione della maggioranza. Ascolta la coscienza e non il potere ed in questo difende i poveri e i disprezzati» (5, 3).
Nei suoi primi tre anni di vita, l’Istituto si è impegnato in questa ricerca, non solo nella normale e quotidiana attività didattico-accademica, ma anche organizzando seminari di studio e congressi per affrontare, alla luce di quella Verità che è «tam antiqua et tam nova», problemi e temi di particolare difficoltà, cercando di mettere in atto un dialogo fra scienziati, filosofi e teologi.
Dopo questo «rodaggio», abbiamo avuto la presunzione di ritenere che fosse di qualche utilità uscire dalle quattro mura dell’Istituto, per mettere a disposizione della riflessione di altri scienziati, filosofi e teologi quanto si va elaborando all’interno del nostro lavoro accademico e di ricerca. Da questo bisogno nasce la presente rivista, di cui questo primo Editoriale vorrebbe fornire la carta d’identità.
Ripensare e riscoprire profondamente la verità del matrimonio e della famiglia, alla luce congiunta della ragione e della fede, è impresa destinata al fallimento se non condotta all’interno di un ripensamento e di una riscoperta della verità della persona umana.
Quando il Santo Padre Giovanni Paolo II diede inizio al ciclo delle Catechesi sull’amore umano nel piano divino, egli affermò che la sua catechesi aveva l’intenzione di «accompagnare, per così dire, da lontano i lavori preparatori al Sinodo» sulla famiglia (cfr Catechesi del 5 settembre 1979; Atti e insegnamenti di Giovanni Paolo II, voI. II/2).
Si trattava dell’attenzione alle profonde radici da cui il tema scaturisce. Quali sono queste profonde radici? È l’humanitas dell’uomo, di ogni uomo: l’humanitas creata nella santità e nella giustizia originaria, l’humanitas caduta nel peccato e a cui è offerta la redenzione operata da Cristo, l’humanitas che sarà glorificata nella fine dei tempi. L’attenzione sulla verità del matrimonio e della famiglia presuppone e implica continuamente l’attenzione sulla verità dell’uomo.
Ma è possibile e doveroso anche il cammino speculativo inverso a questo appena indicato. È possibile e doveroso percorrere la via della riflessione sul matrimonio e sulla famiglia, per penetrare nella verità della persona umana. Questa possibilità, e dovere, è mostrata da molti punti di vista.
Quando il Concilio Vaticano II insegna che l’uomo «plene seipsum invenire non posse nisi per sincerum sui ipsius donum» (Gaudium et spes 24, 3), afferma una verità sull’uomo non di secondaria importanza, poiché essa è radicalmente fondata sull’essere-personale come tale. In questa prospettiva, la meditazione filosofica e teologica su quel dono di se stesso che istituisce la comunione coniugale è un momento impreteribile per sapere la verità dell’amore umano e, in esso, della persona umana. Tanto più che una meditazione filosofica e teologica su questi due temi (amore coniugale - persona umana), è costretta a «fare i conti» con le esperienze essenziali che definiscono, alla fine, la persona umana stessa.
L’amore-dono di sé (coniugalmente realizzato) è possibile per la trascendenza della persona al suo atto e l’immanenza della stessa nel medesimo, per la libertà della volontà che è la base della trascendenza della persona e si esprime eminentemente nella decisione, per la conoscenza della verità sul bene — espressa nelle norme morali — fondamento ultimo della decisione, dell’auto- dominio e della trascendenza della persona nel suo atto. L’atto dell’autodonazione, che definisce l’atto dell’amore, è una strada privilegiata per entrare nello spazio interno dell’humanum: cosa che, forse, non è sempre stata sufficientemente considerata nella grande tradizione antropologica.
Lo schizzo del cammino che, partendo dalla meditazione filosofica e teologica sull’amore coniugale, giunge nel cuore della persona umana, ci fa capire anche che nessun discorso sull’uomo può essere fatto senza una riflessione etica.
La verità dell’uomo è una verità affidata alla libertà dell’uomo: la conoscenza della intelligenza esige di essere riconosciuta dalla volontà. E la riflessione etica si colloca precisamente in questo incrociarsi della verità con la libertà, della conoscenza col riconoscimento: l’etica è l’antropologia normativa. Le norme morali esprimono la potenza obbligante della verità nei confronti della libertà. E quando dall’etica si volesse bandire il concetto di verità, non è solo un pezzo dell’edificio che è tolto: è l’edificio stesso nella sua totalità che è distrutto. E il continuare a parlare ancora di etica, di bene/male, di norme morali, di coscienza morale è un puro esercizio retorico.
Questa rivista si propone — e siamo profondamente consapevoli della difficoltà e della grandezza del compito — di contribuire con tutte le sue forze alla ricostruzione di un pensiero antropologico ed etico, sia filosofico sia teologico, che sia un orientamento chiaro e un criterio veritativo di discernimento per l’uomo d’oggi, sia credente sia non credente. La consapevolezza della nostra povertà ci ha subito convinti che dovevamo unirci a tutti gli uomini di buona volontà, poiché le nostre sole forze sono impari alla realizzazione di questo progetto. Pertanto abbiamo chiesto la cooperazione stabile e organica di uomini che, in sedi prestigiose del sapere scientifico, filosofico e teologico, vedevamo lavorare nella stessa direzione. In questo modo, ci proponiamo di creare — all’interno dell’attuale controversia, sempre più radicale, sull’identità dell’humanum — un centro di pensiero filosofico e teologico che sia fedele alla grande tradizione filosofica ed ecclesiale.
Questa triplice finalità della rivista le conferisce il suo volto preciso e ne delinea, con sufficiente precisione, il progetto di costruzione. Ma le strutture portanti di questa costruzione sono costituite dalle risposte ad alcune domande fondamentali: risposte che orienteranno tutta la riflessione futura. Si tratta della domanda sulla conoscenza della verità, sui fondamenti ultimi dell’etica, sui fondamenti ultimi della riflessione teologica. È sulla base delle risposte a queste tre domande che la rivista intende dare il suo piccolo contributo alla creazione di una cultura adeguata alla verità dell’uomo. Ci sentiamo, pertanto, in dovere di presentare brevemente queste risposte, oggetto della nostra quotidiana riflessione e lavoro accademico.
L’impostazione del problema della verità acquista una sua peculiare fisionomia in relazione alla domanda cui pretende di essere risposta.
Le teorie della conoscenza contemporanee ci spingono a credere che il soggetto del conoscere sia la ragione o l’intelletto o una qualche funzione particolare della coscienza riflettente. Da questo modo di pensare apparentemente innocuo derivano delle conseguenze di enorme rilievo riguardo alla concezione del modo in cui l’uomo incontra la verità, la riconosce e fa esperienza di essa. Una delle conseguenze più letali attribuibili a questa filosofia della conoscenza è una sorta di idealismo, caratterizzato soprattutto dalla presunzione di indifferenza nei confronti della sfera pratica. Una versione della conoscenza non idealistica, né nel senso gnostico né in quello trascendentale, deve ammettere innanzi tutto che non è propriamente l’intelletto a conoscere, ma l’uomo stesso (san Tommaso, De Ver. 2, 6, ad 3). Tale premessa prescrive delle conclusioni di importanza capitale. In primo luogo la conoscenza appare come un momento dell’incontro e della partecipazione dell’uomo alla verità e non più come il luogo esauriente di questo incontro. In secondo luogo si pone il problema della compiutezza di questo incontro e del ruolo specifico che compete alla conoscenza ed ai suoi organi.
Le implicazioni della conoscenza con la verità sono di vario genere e si prestano ad essere considerate da molteplici punti di vista. La presenza del vero, come la verità che può rivelarsi in una presenza, è avvertita dall’uomo con tutto il suo essere e si riverbera perfino nella sfera psicofisica. La capacità di avvertire la verità ha il suo fondamento nell’originaria predisposizione dell’uomo al vero stesso. Essendo creato e preordinato al vero, l’uomo nell’incontro con esso si riscuote perché trova ciò che il suo spirito attende e ciò che risponde al suo desiderio. Ma l’incontro con la verità non diviene pienamente umano finché in questo evento non subentra la facoltà della conoscenza. Attraverso di essa, la verità incontrata diventa in lui una luce stabile cessando di essere una semplice folgorazione. La conoscenza mostra la trascendenza della verità, non permettendo di confonderla con l’esperienza soggettiva che di essa si può avere.
Se però consideriamo la conoscenza non più come conoscenza di qualcosa (nel suo rapporto cioè con l’oggetto), ma come un atto della persona (nel suo rapporto cioè con il soggetto conoscente), ci accorgiamo che attraverso di essa si rivela un particolare aspetto dell’essere che l’uomo è: il suo essere «capace» di verità. Nella facoltà del conoscere, l’uomo manifesta se stesso come un essere aperto al vero e alla trascendenza della verità e, nello stesso tempo, è proprio nella dipendenza dalla verità che appare la trascendenza della persona.
Una ulteriore conseguenza che dobbiamo trarre da questo abbozzo di definizione della conoscenza e della verità è ciò che raggiunge l’uomo nel profondo di sé e che quindi non può entrare in lui senza orientarlo eticamente: chiama in causa la sua libertà. Alle affermazioni vere che lo riguardano, e quindi lo definiscono, l’uomo non può aderire con il solo intelletto senza che sia coimplicata la sua libertà.
Il nodo fondamentale da sciogliere a proposito della verità della conoscenza è quello del giudizio: della corrispondenza fra ciò che è affermato e l’essere di ciò che entra nella relazione conoscitiva. Si tratta di una specificazione successiva dell’aspetto per cui la conoscenza è conoscenza «di qualcosa». La verità della conoscenza si stabilisce nella verifica della corrispondenza fra l’affermazione e l’essere della cosa («veritas fundatur in esse», san Tommaso, in I Sent., disp. 19, q. 5, a. 1) tenendo presente che diversa è la natura delle «cose». San Tommaso ha posto chiaramente il principio per cui oggetti di natura diversa si rivelano in maniera differente e mettono quindi capo a conoscenze di diverso tipo (cfr Contra gentes 4, 11).
La consapevolezza della «distinzione dei gradi del sapere» è particolarmente importante nel nostro lavoro, poiché in esso convergono conoscenze scientifiche, filosofiche, teologiche, per rifiutare ogni visione riduttivistica del criterio veritativo.
Ma questa consapevolezza non deve farci dimenticare che essa presuppone una visione unitaria di quell’unicum-unum che è la persona umana, che recupera la verità del teorema della «subalternanza», in ordine ad una «antropologia adeguata» (cfr Giovanni Paolo II, Catechesi del 2 gennaio 1980, nota 1; Atti ed insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. III).
Quanto è stato detto sulla conoscenza della verità è per noi conditio sine qua non per dare inizio a un dialogo sincero e fruttuoso coi lettori della nostra Rivista sui principali problemi attuali dell’etica. Se le norme morali e i giudizi etici non dovessero avere valore veritativo, se fossero solo espressione del consenso sociale, se, all’opposto, fossero unicamente espressione dei sentimenti soggettivi di approvazione o disapprovazione oppure delle decisioni individuali interamente condizionate e regolate dalla situazione, quale senso avrebbe avviare un dialogo su tali argomenti? Nei confronti dei sentimenti soggettivi, presi nella loro fattualità, la discussione non ha alcun senso dal punto di vista scientifico; lo può avere soltanto come propaganda a scopo di cambiare i sentimenti altrui a proprio profitto, ma questo non ci interessa. Il fatto che ancor oggi si parli, a livello personale, sociale e politico, dei problemi etici presuppone necessariamente la convinzione che su di essi c’è una verità oggettiva, un criterio cioè che permette di capire se le svariate emozioni e giudizi individuali siano giusti oppure sbagliati e quindi da correggere.
Il riconoscimento del valore di verità delle norme e dei giudizi etici viene quindi imposto da ciò che riteniamo debba essere la nostra onestà come autori di una Rivista. E il principio della verità delle norme racchiude in sé il problema dell’essere e della fondazione metafisica dell’etica. Senza essere, a cui si adegui il pensiero e la coscienza, non c’è verità. Essa non può venire oggettivamente fondata sui processi logici, psicologici o trascendentali della soggettività, né sui condizionamenti istintuali o sociologici che essa possa subire. Dunque, siamo portati a riconoscere l’esistenza di realtà — e anche di fenomeni di coscienza legati alla libertà come il senso del dovere, il rimorso, il pentimento, la conversione — originariamente morali, quali sono ad esempio i valori che definiscono lo sviluppo integrale dell’uomo come persona.
Da quei valori vengono ricavati i criteri per conoscere ciò che è bene e ciò che è male nell’agire dell’uomo, per determinare cioè la moralità del suo comportamento. Essa sarà non di rado una moralità intrinseca — posseduta dall’atto in se stesso, nel suo significato costitutivo — perché altrimenti non avrebbe alcun senso attribuire un valore di verità alle norme etiche universali.
Tutto ciò non dovrebbe venir inteso come una mancanza di rispetto da parte nostra verso la singolarità irripetibile di ogni uomo e di ogni suo comportamento concreto, nemmeno come misconoscimento della sacralità della coscienza. Significa invece che la relazione dell’uomo che agisce, con la propria e l’altrui dignità di persona umana e di figlio di Dio, costituisce il contesto-base ed essenziale di ogni scelta e di ogni coscienza. In questo contesto necessario di ogni atto della persona è racchiuso l’oggetto principale della responsabilità etica; quindi non possiamo ammettere che essa venga subordinata sempre ed esclusivamente ad una strategia di massimalizzazione dei valori extraetici, a una funzione universale di utilità che giustificherebbe qualsiasi comportamento da essa richiesto (diverse forme, anche teologiche, di utilitarismo etico). La responsabilità nei confronti del mondo, se contrapposta alle esigenze irrinunciabili della dignità dell’uomo redento da Cristo, perde ogni sua eticità.
Le particolari condizioni della società contemporanea e i progressi tecnologici del nostro tempo allargano certamente la responsabilità dell’uomo, così che, alle volte, risulta difficile per una intelligenza finita la valutazione esatta della portata dei suoi atteggiamenti e dei suoi atti. Pochi arriverebbero, con una metodologia empirico-induttiva, a una valutazione appena accettabile. Ciononostante, riteniamo che sempre sia possibile per l’uomo — senza sottomettersi agli strateghi del benessere — conoscere e fare ciò che è bene, e conoscere e tralasciare ciò che è male. Anche questo fatto ci spinge ad ammettere, sul piano strettamente razionale e filosofico, Dio come sommo Legislatore morale e fondamento ultimo del dovere, e a riconoscere la luce naturale della ragione (conoscenza etica naturale) come partecipazione dell’infinita luce della Ragione divina.
Non riusciamo a capire quindi in che maniera la luce divina proiettata sull’essere e sull’agire dell’uomo potrebbe oscurare la libertà e la legittima autonomia della persona. La libertà risiede nel fatto che i princìpi secondo cui l’uomo agisce siano da lui capiti, accettati e interiorizzati, non nel fatto che questi princìpi abbiano la loro sorgente ultima nell’umana finitezza. Che il prezioso dono della libertà sia inscindibilmente legato all’assurdità di un mondo finito a sé stante, oppure a un deismo che ci toglie la gioia di un personale rapporto di amicizia con Dio, ci sembra una contraddizione.
Il «caso serio» dell’etica, solo così salvaguardato, ci introduce pertanto nel «caso serio» — l’unico vero «caso serio» — della relazione dell’uomo con Dio, dalla quale dipende l’eterna salvezza della persona creata. E, dunque, nell’ambito della riflessione propriamente teologica.
La riflessione teologica su un’antropologia adeguata esige nel panorama teologico contemporaneo la messa a punto di elementi fondamentali, cui la nostra Rivista intende attenersi. Anzitutto, in buona teologia, il criterio veritativo non può limitarsi neppure all’intrinsecamente vero: «La revelatio revelata, un preciso messaggio inviato da Dio agli uomini, deve essere ricevuta […] come nozione assolutamente certa in quanto ci proviene da Colui che non può né ingannare né essere ingannato» (J. H. Newman, Grammatica dell’assenso, Milano 1980, p. 240). È l’idea ricca di tradizione, dell’assenso di fede che alla fine coincide con l’abbandono all’autorità di Dio documentatasi in Cristo. Ciò esige il riconoscimento del principio di autorità nella conoscenza della verità cristiana. L’autorità di Cristo anzitutto, e quindi del Magistero come interprete autentico di Bibbia e Tradizione.
In secondo luogo, il cristianesimo, pur essendo carico di ragionevolezza è, nel suo nucleo centrale, Mistero. È l’irruzione nella storia di un Altro che resta strutturalmente oltre la natura e la ragione dell’uomo pur cogliendone a fondo le esigenze. L’idea di Mistero soprannaturale — già messa a punto dallo Scheeben nel secolo scorso — resta la chiave corretta per riproporre ancora oggi i contenuti ultimi della fede cristiana. Quando si oscura questa idea si ha l’ingresso del razionalismo nel pensare teologico, che è il pericolo più grave per la fede, come ben vide Newman (cfr «On the introduction of rationalistic principles into revealed religion», in Essays critical and bistorical I, London 1907, pp. 30-99).
Occorrerà riaffermare con vigore la centralità di Cristo come contenuto fondamentale dei Misteri soprannaturali. Nella redenzione infatti l’uomo, mediante la fede e il battesimo, è incorporato a Cristo nella Chiesa. Divenuti Filii in Filio gli uomini sono introdotti da Cristo nella vita intima della Trinità e quindi condotti alla scoperta del livello sublime della Comunione interpersonale.
L’antropologia cristologicamente, e quindi trinitariamente, radicata diviene così contenuto fondamentale della nostra Rivista. Essa prenderà allora in esame i temi essenziali di una sana antropologia filosofica, nel convincimento, profondamente metafisico, che essi sono caratterizzati da polarità: spirito/corpo, maschio/femmina, individuo/società. Lo sforzo di ogni antropologia «precristiana» è sempre stato quello di dare risposta soddisfacente al problema dell’unità dell’uomo nonostante che quella struttura polare faccia sentire il suo peso — a livello di ciascuna delle tre dimensioni citate — attraverso il grande punto interrogativo della morte. Riconoscendo la validità e la necessità di un’antropologia naturale, a carattere filosofico, la novità cristiana ne documenta l’effettivo inveramento in Cristo Uomo-Dio.
Anima e corpo perdono nel Risorto ogni possibile tensione perché nel descensus glorioso di Cristo si produce una sorta di trasfigurazione della corporeità (cfr Col 1, 13). Nel rapporto tra Cristo e la Chiesa, Paolo (cfr Ef 5) indica la radice risolutiva di ogni tensione sessuale fra uomo e donna.
Infine la comunione interpersonale fondata dall’evento trinitario fa intravedere la possibilità di superamento, nel rapporto «persona» e «comunità», della tensione fra individuo e società.
Sono temi per forza di cose solo accennati in questa sede, sui quali la nostra Rivista non cesserà di riflettere dal momento che l’Istituto stesso, di cui sarà espressione ufficiale, vive uno dei suoi fondamenti nel continuo dialogo antropologico tra scienza, filosofia e teologia.
Con semplicità e fermezza immetteremo nell’ideale agone costituito dal necessario dibattito scientifico, filosofico e teologico le nostre convinzioni saldamente comprovate. Ci spinge a ciò non solo la posizione di quanti hanno inteso porsi al di fuori e «dopo» il cristianesimo in un atteggiamento culturale che viene preteso come postcristiano, ma anche il constatare che per molti cristiani è purtroppo reale il rischio di una vanificazione del Mistero soprannaturale come cuore del cristianesimo. Le lacerazioni della teologia postconciliare sono significativa conferma della tentazione di ridurre il cristianesimo ad una religio, vale a dire ad uno dei fattori della polis, perciò ad elemento, in ultima istanza, inincidente nella storia, perché non «diverso», non «altro» da essa.
La messa in discussione, da parte di molti, del significato teologico di dogmi fondamentali, come — per fare esempi — la divinità e la risurrezione di Cristo, la transustanziazione, così come la struttura stessa della morale e della funzione del Magistero nella Chiesa e nella teologia, sembra dipendere da questo ricorrente equivoco che nel pensiero moderno si documenta: la pretesa di dimostrare le verità della fede mediante i soli principi della ragione. La fragilità di una simile posizione non è solo teologica ma anche filosofica. Essa infatti fa riferimento spesso ad un uso illuministico di «ragione». Una ragione in sé illuministica, ma in concreto indebolita da condizionamenti psicosociali; in una parola, che si lascia tentare dal fideismo. Il fideismo è un uso della ragione, in nome della fede, che vanifica le ragioni della fede.
Consideriamo questo come il quadro realistico della situazione odierna. Come si vede non siamo preda di facili ottimismi, anche se sono molte e valide le ragioni che ci inducono a sperare. Tra queste, lo diciamo perché la cosa ci riguarda molto da vicino come studiosi, l’originalissimo e dottrinalmente provocante Magistero di Giovanni Paolo II sui contenuti quotidiani del nostro lavoro e, perciò, della Rivista.
|