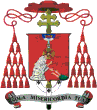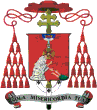L’istruzione «Il dono della vita”: una introduzione alla lettura
Cultura e Libri, maggio 1987
«…et jam a figura
veritatem discernunt»
(sant’Atanasio)
La comprensione dell’Istruzione “Il dono della vita” (Donum Vitae) presuppone nel lettore — come condizioni necessarie — alcuni atteggiamenti spirituali, necessari peraltro ogni volta che l’uomo affronta i supremi problemi dello spirito.
1. Alcune premesse alla lettura dell’Istruzione
Se sottoponessimo ad analisi chimica la Pietà di Michelangelo, il risultato non sarebbe per niente diverso che se alla medesima analisi sottoponessimo un qualsiasi pezzo di marmo.
Se, sulla base del risultato suddetto uno concludesse che non esiste nessuna diversità reale fra i due blocchi, chiunque resterebbe stupito ed incredulo; come è possibile equiparare la Pietà ad un qualsiasi pezzo di marmo? È possibile, precisamente, solo se e solo quando non si vede altro che marmo nella Pietà. La realtà si svela a chi ha occhio per vederla. Ora l’occhio può essere più o meno penetrante. Dedurre dalla propria capacità visiva o misurare la realtà secondo questo criterio equivale a precludersi l’ingresso intellettivo dentro la parte più profonda di essa. La prima grande descrizione di questa legge dello spirito è stata fatta da Platone, come è noto, nel Fedone, 96 A-102 A (1), ove si parla di una “duplice navigazione” verso la Verità. L’una che non sa andare oltre a ciò che offrono i sensi, la seconda che passa dal piano fisico al piano meta-fisico. E la seconda navigazione è così difficile che abbiamo subito la tentazione di lasciarla fin dal principio: “fatica che pochi si rassegnano ad affrontare per amore del sapere, pur avendone Dio posto in tutte le anime il desiderio naturale” (San Tommaso, Summa Contra Gentiles lib. 1, 4). Non solo, ma chi si ferma alla prima navigazione, considera folli o illusi coloro che si avventurano nella seconda. Che ha a che fare con l’Istruzione Donum Vitae questa riflessione? Essa descrive la prima condizione spirituale per capirla. Se uno non sa andare oltre, coll’esercizio della sua intelligenza, alla descrizione dei vari processi biologici, alla loro quantificazione, alla verifica dei loro risultati, se uno, non sapendo e non volendo andare oltre, ne conclude, come spesso avviene, che i processi biologici cui si riferisce la Donum Vitae non sono altro che questo, questi non deve neppure cominciare a leggere questo documento; perde il suo tempo (2).
La seconda premessa è conseguenza della prima. Essa consiste, in breve, nella capacità di vedere, di percepire quella che potremmo chiamare “l’umiltà del valore etico”. È nota la famosa tripartizione pascaliana dei tre ordini in cui si collocano i beni. Ora possiamo constatare ogni giorno che i beni appartenenti al primo ordine (potere, ricchezza...) hanno bisogno per farsi vedere di mostrarsi in un contesto di grandezza. Che ricchezza sarebbe quella che non si mostra mai? che potere sarebbe quello che non si esercitasse mai con tutta la forza che possiede? Ma come ci lasciamo alle spalle questo primo ordine dei beni ed entriamo nel secondo, constatiamo che i beni non hanno più bisogno di questo contesto. Essi sono “umili”. Ad un giovane che si lamentava che non fosse riconosciuto nella sua intelligenza, Tommaso Moro rispose: “non sei conosciuto dalle Tre Persone della Trinità e dal tuo angelo custode e questo non ti basta?” Forse che il valore scientifico delle scoperte di Einstein sarebbe superiore, se egli avesse accettato di divenire capo dello Stato d’Israele, come gli fu offerto? Esistono delle realtà che collocate nel primo ordine assiologico — l’ordine della superbia mondana — farebbero una pessima figura: in realtà sono di un altro ordine. Fra queste è lo zigote umano. Che potere ha, che splendore? Nessuno. È perfino invisibile. Eppure, egli vale più che l’universo materiale insieme. Questo, infatti, finirà, ma quegli è immortale, soggetto di un destino eterno, termine di un atto creativo di Dio. I più grandi beni sono spesso presenti nei fatti più piccoli ed apparentemente insignificanti. Il valore morale, fra questi, è un valore umile. La vecchietta, sporca e cenciosa, che ogni mattina siede sui gradini della Basilica di San Giovanni vale più che la Basilica stessa con tutto il suo splendore. Essa è stata costruita per essere la degna casa anche di lei, quando volesse adorare e lodare il Signore. La Donum Vitae vede nei più umili processi biologici dei valori sublimi. Chi si ferma alla prima navigazione, ride di questa visione e se ne meraviglia. È come meravigliarsi del fatto che attorno alla Pietà di Michelangelo è stato messo il cristallo antiproiettile, mentre questo non è stato fatto per i pezzi di marmo che sono in qualsiasi cava. Chi non ha mai visto in vita sua l’umiltà del valore etico o non se ne è stupito, è meglio non cominci neppure la lettura di questa Istruzione.
La terza premessa parte da una constatazione. Nel suo cammino che “dall’infima lacuna dell’universo!” ha portato Dante “verso l’ultima salute”, egli è stato guidato da Virgilio e da Beatrice: dalla ragione e dalla fede. Esse sono i due occhi dello spirito. Ora, in molti oggi viene rifiutata la seconda luce; la prima è stata “abbreviata”, interdicendole di andare oltre le apparenze. Non resta che lasciarsi guidare dalle emozioni, dai desideri, attraverso un calcolo dei costi e benefici che ogni attività comporta. L’operare dell’uomo è stato ridotto al suo fare. Ciò ha avuto una conseguenza di incalcolabile portata: la preclusione della possibilità stessa di percepire il bene morale nella sua solitaria incoordinabilità con qualcosa di utile-dannoso e/o di piacevole-spiacevole. In una delle sue pagine che a me sembrano fra le più belle da lui scritte, san Tommaso distingue col suo abituale rigore, il male morale (malum culpae) dal male di altro genere (malum poenae). Il primo è il male che si insedia nella libertà della persona: in ciò che decide del senso stesso della storia della persona. Il secondo si situa al di fuori (3). Ci sono beni morali che possono non piacere o essere dannosi; ci sono mali morali che possono essere utili o piacevoli, soddisfare cioè dei desideri, per altro legittimi. Cogliere questa distinzione, elevarsi al punto di vista etico, passare dallo “stadio estetico” allo “stadio etico”, direbbe Kierkegaard, è assolutamente necessario per capire l’Istruzione.
E siamo così alla quarta e più importante premessa. Partiamo da un semplice esempio. Proviamo a fare una domanda: per quale ragione Tommaso Moro non ha firmato l’atto di supremazia regia, non è uscito dalla prigione, ha accettato la decapitazione? Uno potrebbe rispondere: perché non ha mosso la sua mano nel movimento proprio di chi scrive il proprio nome, non ha mosso le sue gambe e così via. Si vede subito, però, che questa risposta realmente non risponde alla domanda, Essa, infatti, indica ciò mediante cui Tommaso Moro ha fatto ciò che ha fatto, ma non indica minimamente la ragione che ha spinto il martire ad agire come ha agito, servendosi ovviamente dei suoi organi fisici: direbbe Platone, “la causa reale”. Questa è da collocarsi, originariamente, in un atto intellettivo col quale Tommaso Moro ha visto che l’atto di obbedire al re era in se stesso moralmente illecito.
Si possono giudicare i propri atti in base alle conseguenze che essi possono avere per noi e/o per gli altri oppure si possono giudicare in se stessi e per se stessi prescindendo dalle loro conseguenze. L’Istruzione si muove in questa seconda prospettiva, quella propriamente etica e per leggerla occorre mettersi in questa prospettiva (4).
2. I presupposti filosofici
Se il lettore si pone nella prospettiva indicata dalle quattro premesse precedenti, può comprendere il discorso dell’Istruzione Donum Vitae. Per guidare questa comprensione, occorre, tuttavia, individuare alcuni presupposti filosofici.
Potrebbe sorgere una difficoltà. Che diritto ha la Chiesa di appellarsi a verità che sono semplicemente razionali? E che la Chiesa sia cosciente di muoversi in questo piano, con questa Istruzione, è molto chiaro, soprattutto nella quarta parte del documento. La risposta può essere data, a seconda che chi avanza la domanda, la pone come credente o come non credente.
(A) Come credente. Secondo un lucido insegnamento di san Tommaso (Contra Gentiles, loc. cit.) — fatto proprio dal Vaticano I — “la divina bontà provvide salutarmente a comandarci di tenere per fede anche verità conoscibili con la ragione: affinché tutti possano con facilità essere partecipi della conoscenza di Dio, senza dubbi e senza errori”. L’osservazione del dottore angelico è di particolare attualità, poiché oggi viviamo in una cultura, costruita pressoché completamente sulla “prima navigazione”. Una cultura, quindi, nella quale pochi, con difficoltà, in mezzo a grandi incertezze ed errori, possono raggiungere queste verità, che sono, per altro, le più importanti per la vita dell’uomo. Ma c’è anche una seconda ragione che fonda il dovere della Chiesa di entrare nel campo della verità puramente razionale, come la dottrina cattolica insegna, l’atto di fede è formalmente un atto (un assenso) della ragione e la virtù della fede inerisce alla facoltà intellettiva. Ne consegue che — come per altro la storia del pensiero cristiano documenta ampiamente — la ragione deve essere disposta per questa elevazione sublime. In altre parole; non ogni visione filosofica è disponente la ragione a credere. Come può ragionevolmente credere, chi nega l’esistenza di realtà invisibili ai sensi, chi nega la libertà della persona? Radicandosi in una ragione mal disposta, la fede ha vita breve. Ma è vero anche il rapporto reciproco. La fede guida la ragione a scoprire delle verità che, scoperte sotto questa guida, appaiono poi evidenti anche razionalmente. Si pensi al guadagno che la ragione come tale ha ricavato dalla Rivelazione, scoprendo la verità, metafisicamente centrale, della creazione e la verità, eticamente fondamentale, della persona. Si dà un nesso, dunque, fra ragione e fede, una specie di circolo, nel quale si costruisce il pensare cristiano: non meno cristiano perché “pensare” — non meno “pensare” perché cristiano. Hegel stesso ha riconosciuto la grandezza speculativa di questo pensiero (5). La Chiesa non difende solo la fede, difende anche la ragione. C’è a volte nei teologi, al riguardo, un atteggiamento di disprezzo verso il lavoro della ragione. Si considera la filosofia come “strumento” per esprimere la fede. Essa non è questo: essa, in primo luogo, è ricerca della verità. E se non ogni filosofia può essere assunta dalla fede, è perché non ogni filosofia è vera. E non perché è meno adatta a far comprendere o a dire la fede: questa è una preoccupazione assolutamente di secondaria importanza.
Si pone, oggi, sempre nel contesto della Chiesa cattolica, un problema particolarmente grave, al riguardo. Riconosciuta la competenza della Chiesa nell’ambito diciamo del “per sé razionale”, si nega che questa competenza abbia la stessa autorità di quella con cui la Chiesa insegna, il “per sé rivelato”. Mentre nel secondo caso, gode di un’autorità vera e propria cui si deve l’obbedienza della fede, nel primo caso essa non gode di una vera e propria autorità e, pertanto, il suo insegnamento vale tanto quanto valgono le ragioni portate (6). Valore che è ultimamente giudicato dalla ragione di chi è competente in materia: al magistero pontificio-episcopale è parallelo il magistero scientifico (dei teologi). Tralasciando il problema di un magistero di verità speculative, mi limito a quello delle verità morali. I giudizi etici — come sappiamo — hanno come loro soggetto l’atto della persona, dei quali si afferma/si nega la liceità etica. Nella prospettiva dei credenti, liceità/illiceità etica equivale a ordinabilità/inordinabilità dell’atto giudicato al fine ultimo dell’uomo, la vita eterna. Ora, guidare l’uomo alla salvezza eterna non è uno dei compiti dei Pastori della Chiesa: è il compito loro. Per questo, non per altro, essi sono costituiti: “cellerari del Sangue”, direbbe santa Caterina da Siena. Affermare che non hanno nessuna autorità come Pastori di insegnare se un atto è buono o cattivo, se questo non è già detto esplicitamente o implicitamente nella Rivelazione, equi vale a dire che essi sono investiti dalla Provvidenza di Dio di una responsabilità (e come è terribile questa responsabilità!), ma privati di ciò che è assolutamente necessario per adempierla. È chiaro, infatti, che nel corso della storia, l’uomo raggiunge delle possibilità di cui la Rivelazione non parla: come — ed è il nostro caso — la possibilità di porre le condizioni per un concepimento umano prescindendo dalla congiunzione sessuale.
(B) Come non credenti. È ovvio che, in questo caso, la Chiesa fa appello alle esigenze della ragione: Essa si presenta come preoccupata della dignità dell’uomo come tale e chiede solo di percorrere il cammino (la navigazione) della riflessione, di cui offre le tracce. Essa ha una grande stima della ragione, perché sa che questa è luce posta nell’uomo da Dio, luce che non può mai contraddire la fede. E è dunque certa che chi segue la sua riflessione, giunge alla verità.
Quali sono, dunque, i presupposti dell’Istruzione Donum Vitae, dal punto di vista filosofico?
2, 1. Il primo — di cui non si può esagerare l’importanza — è il concetto di persona, come espressivo di una realtà dotata di un valore incondizionato. È forse il punto teoreticamente più importante di tutto il documento. Esso esige una riflessione attenta e mai, come in questo caso, è necessaria la“seconda navigazione” (7).
Una delle vie più semplici per giungere all’intuizione dell’essere-personale è la riflessione sull’atto libero (8). Ora ciò che noi “sentiamo” spiritualmente, quando compiamo un atto libero, discernendolo subito da ogni altro atto, è che noi sentiamo che di esso noi siamo causa, tanto è vero che solo di esso noi assumiamo la responsabilità. Che significa “siamo causa di…”? La nostra esperienza ancora ci dice che “essere causa di...” significa “essere all’origine di…” nel senso che ciò di cui si è causa dipende da se stessi quanto all’essere. Si noti bene; è una dipendenza nell’essere. L’atto (compiuto) è, perché è posto nell’essere da me. Esso non ha causa — nel senso appena detto — all’infuori del soggetto che agisce (9).
Questa indipendenza nell’operare (esclusione di altre causalità) non può spiegarsi se non sulla base di una indipendenza nell’essere. Sarebbe semplicemente assurdo negare questa inferenza. Che cosa significa “indipendenza nell’essere”? L’espressione denota una naturale intuizione che la metafisica classica ha espresso colla distinzione fra sostanza e accidente. È intuitivamente evidente che il colore bianco di una parete è altro che la parete stessa, proprio dal punto di vista del loro modo di essere. Il colore è, in quanto è la parete che, per il colore con cui è stata dipinta, è bianca: l’essere del colore consiste nell’inerire ad una parete. Per cui, il colore dipende nel suo essere dalla parete, ma non viceversa. Possiamo, dunque, dire che la sostanza non è altro che questa realtà alla cui essenza o natura compete l’essere in sé e non in un altro soggetto. Questo significa “indipendenza nell’essere” che tecnicamente si usa chiamare “sussistenza“. Già fin da ora possiamo renderci conto che la dignità, la nobiltà ontologica della sostanza è superiore a quella dell’accidente, poiché “gli accidenti, in quanto non sussistono, propriamente non hanno l’essere, ma piuttosto il loro soggetto è, in un modo o nell’altro, secondo questi accidenti” (San Tommaso, De Veritate q. 27, a. 1, ad 8um). Ma su questo ritorneremo più avanti.
Che cosa fa sì che la sostanza sussista, a che cosa cioè essa deve questo suo carattere distintivo nel quale risiede la sua nobiltà ontologica? al possesso di un suo proprio atto di essere. Come dice profondamente san Tommaso “esse uniuscuius que est ei proprium et distinctum ab esse cuiuslibet alterius rei” (Qq. dd. de Potentia, q. 3, a. 7, Resp.; si veda anche Contra Gentiles lib. 1, cap. 44, 2 e in I Sent. 19, 5, 2 sol.). Tuttavia, si deve subito notare che l’atto d’essere proprio della sostanza, attualizzando una essenza che esige per sé di sussistere, fa sì precisamente che ciò che è per atto d’essere proprio, sia in se stesso.
Giunti a questo punto, abbiamo tutti gli elementi per cogliere lo statuto ontologico, per sapere la verità della persona (10). Ogni persona, come ogni sostanza, è in sé, sussiste per il possesso intrinseco di un suo proprio ed esclusivo atto di essere. Se ora vogliamo cogliere tutta l’intensità di questo atto, dobbiamo tenere presente che la persona sussiste poiché la sua essenza — la sua potenzialità di essere — è una essenza puramente spirituale, che non ha in sé nessuna materia. E lo spirito, per sua stessa definizione, esige di essere in sé, come il circolo, per sua stessa natura, esige la rotondità. L’atto della libertà, nella sua pura ed escludente causalità, ci rivela questa sublime proprietà dello spirito. Il termine “sublime” non è retorico, è assolutamente rigoroso: la natura propria dello spirito fa sì che non sia concepibile metafisicamente un modo di essere più alto che quello in cui si pone la persona nel momento in cui è. Infatti, mentre ogni individuo (dunque ogni sussistente) non personale è certamente in sé, tuttavia per il fatto che la materia entra nella costituzione della sua essenza con pari diritto che la sua forma propria, e poiché — ancora — la materia per sua stessa costituzione è in continuo mutamento e realtà non stabile (11), l’individuo è per sua natura realtà contingente. Il suo atto d’essere e quindi il fatto del suo esistere possiede un così basso grado di intensità, perché continuamente esposto alla corruzione, condizionato dal perdurare nel tempo dei suoi costitutivi materiali. Al contrario, la persona, a causa dello spirito. La natura dello spirito determina un modo di sussistenza necessaria. Necessaria nel senso che il suo atto di essere non è condizionato da nulla. La persona non è corruttibile, essa è eterna, per sua natura stessa (12).
La nobiltà, la dignità ontologica della persona è infinitamente superiore a tutti gli altri enti creati: essa si pone in un grado dell’essere la cui distanza dai gradi degli altri enti è infinitamente infinita, per usare il vocabolario pascaliano. Mentre, data la diversa costituzione ontologica, l’individuo non personale è un “momento” di una linea, una parte di un tutto, un passeggero evento del disporsi della materia, la persona è in sé, non è parte di un tutto, è un soggetto eterno. I primi non sono per sé, ma per l’insieme (l’individuo animale è per la specie ed ogni specie si inserisce nel contesto della natura); la persona è per sé: quando il biologo parla di “specie umana” usa un termine che ha un significato del tutto diverso da quello usato dal metafisico e dal teologo. Mentre, quindi, la Provvidenza divina provvede generalmente agli individui impersonali, in quanto servono ad altro, la Provvidenza divina provvede ad ogni singola persona: per se stessa e non in quanto serve ad altro.
Questa nobiltà ontologica della persona è il fondamento ed il principio del giusto, retto rapporto verso essa: questa deve essere voluta per se stessa. Qualsiasi uso di qualsiasi persona è la distruzione dell’ordine onto-assiologico dell’universo dell’essere. L’Istruzione non fa che applicare questo principio ai vari problemi posti dalle odierne biotecnologie (13).
2, 2. La fondazione della nobiltà, sublime ontologicamente, di ogni persona sembra dover concludere colla esclusione da questo atto di stima suprema del corpo umano. Se, infatti, la sussistenza propria della persona — che è il titolo metafisico della sua nobiltà — è dovuta alla sua natura spirituale, il corpo può essere trattato in modo diverso. Al contrario, l’Istruzione Donum Vitae afferma l’unità della persona, al punto che ciò che viene detto della persona, non deve essere ridotto alla persona-spirito, ma alla persona-corpo anche. In un parola: alla persona nella sua uni-totalità corporeo-spirituale. Anzi, nella presentazione ufficiale fatta dal Cardinale Ratzinger, è detto che questo è uno dei presupposti fondamentali di tutto il documento. Si sa che questa è stata una delle difficoltà più gravi (rapporto persona- corpo) avvertite nel pensiero cristiano.
L’Istruzione, parlando di uni-totalità della persona umana, non presenta in primo luogo una teoria esplicativa, ma descrive un fatto, di cui la nostra esperienza è continuamente testimone. Ciascuno di noi è al contempo consapevole di compiere attività puramente spirituali, attività psichiche e fisiche e di essere lo stesso soggetto che agisce o spiritualmente o psichicamente o fisicamente. Qualunque spiegazione deve rendere conto, ragione di questo fatto, senza negare nessuna delle due componenti (unità del soggetto-molteplicità delle operazioni). Ora, lo schizzo di fondazione metafisica della dignità della persona sopra abbozzato non solo non impedisce una spiegazione siffatta, ma è l’unica — a mio giudizio — a renderla teoreticamente possibile.
La soggettività (nel senso ontologico, non nel senso del trascendentalismo moderno) è connessa allo spirito, come la rotondità al circolo: su questa connessione non dovrebbero esserci dubbi. Allora il corpo non è parte costitutiva della persona? o la persona non è unificata? La risposta a questa domanda è teoreticamente complessa.
Il punto di partenza fondamentale è l’affermazione che non solo l’atto d’essere (per cui ciò che è è) appartiene in proprio a ciascuno (“unumquodque est per suum esse” dice san Tommaso in Contra Gentiles lib. 1, 22, 5), ma che non può essere che uno solo (cfr. ibid. lib. 1, 42, 17). Se l’atto d’essere per cui ciascuno è non fosse uno solo, ciascuno non sarebbe uno, non possederebbe più una sua unità ontologica, ci sarebbero in realtà due o più esistenti, uniti in una accidentale aggregazione. D’altra parte, essere è sempre essere qualcosa (un angelo, un uomo, una pianta). Quel “qualcosa” determinato, misurato precisamente dall’essenza propria di ciascuno. Poiché l’esperienza ci attesta che l’uomo non compie solo operazioni puramente spirituali, la sua essenza-natura è costituita non solo dallo spirito, ma anche dalla materia. Il nodo teoretico sta precisamente in questo: da una parte, l’unità di cui l’uomo è consapevole (è lo stesso soggetto che agisce spiritualmente e corporalmente) esige l’unità dell’atto d’essere per cui l’uomo è; dall’altra parte la pluralità delle operazioni di cui l’uomo è consapevole (è essenzialmente diverso agire spiritualmente ed agire corporalmente) esige, sembra, la pluralità degli atti di essere, dal momento che l’essere è diversificato non da se stesso, ma dalla essenza che lo riceve (“res propter hoc differunt, quod habent diversas naturas quibus acquiritur esse diversimode”, Contra Gentiles lib. 1, 46, 3; si veda anche Qq. Dd. de Potentia q. 7, a. 2, ad 9um). Per stringere, alla fine, il punto: l’unità del soggetto esige l’unità dell’atto d’essere; la molteplicità delle operazioni esige la pluralità dell’atto d’essere. Il che equivale a dire: o la persona è il suo corpo o è il suo spirito, ma non può essere “corpore et anima unus” (come dice Gaudium et Spes) (14).
E qui occorre fare un secondo passo teoretico, che troviamo esposto coll’abituale rigorosa brevità e chiarezza da san Tommaso nella q. dist. de anima, a. 1, ad 17um: l’essere è massimamente comunicabile. Se noi ci poniamo nella prospettiva logico-formale di chi considera le essenze delle cose, noi siamo imprigionati, senza possibilità alcuna di fuga, dentro la legge della opposizione per contrarietà. L’essenza dell’angelo non è l’essenza dell’uomo, e così via. Ma, quando parliamo dell’essere questa prospettiva deve essere abbandonata: l’essere non è una essenza con minimo di comprensione e massimo di estensione. È forse questo il più grave errore in cui l’intelligenza può cadere. L’essere non è l’essenza, ma è ciò per cui un’essenza è. L’essere trascende le determinazioni delle essenze tutte, non perché sia un’essenza suprema, ma perché è l’atto di tutte. In questo sta l’infinita comunicabilità dell’essere, il suo non lasciarsi imprigionare da nessuna. Anzi, quanto più intenso è l’atto d’essere, tanto più è comunicabile.
Ritorniamo ora al nostro problema, Lo spirito umano è per il suo proprio atto d’essere. Questo stesso atto d’essere è comunicato al corpo e, pertanto, ogni uomo non è due enti, ma un solo soggetto esistente. La soluzione del difficile problema dell’uni-totalità della persona umana è offerta dalla nozione di essere che, trascendendo l’ordine delle essenze, può unire in un solo atto d’essere — e quindi in un solo esistente — un’essenza immateriale come l’anima umana ed una realtà materiale come il corpo umano (15). Possiamo esprimere questa stessa soluzione in altra forma. L’unità della persona umana è dovuta all’unità del suo atto d’essere. L’atto d’essere attualizza sempre un’essenza. Poiché ciò che entra nella definizione di persona umana non è solo lo spirito, ma anche la materia, l’atto per cui la persona umana è, fa essere sia il corpo sia lo spirito. Non tuttavia, allo stesso modo. Infatti, allo spirito l’essere nel modo della sussistenza è dovuto per sé; al corpo (alla materia) mediante lo spirito (la forma). Il corpo è, in quanto possiede lo stesso atto d’essere che lo spirito. Poiché, negli individui non personali, la loro forma non può esistere se non nell’unità colla materia, corrotta questa, è l’individuo stesso che cessa di essere. Poiché nella persona umana, la forma è puramente spirituale, essa è per se stessa ed in se stessa sussistente e anche quando il corpo — come ogni realtà materiale — si corromperà, lo spirito, l’io personale permane per sempre. Lo spirito comunica il suo essere al corpo, senza che questa comunicazione de-gradi il suo modo di essere; al contrario, questa comunicazione eleva il corpo umano ad essere precisamente il corpo di una persona (16). Non degrada lo spirito, ma eleva il corpo: quanto più intenso è l’atto d’essere, tanto più è comunicabile. Quando non si tiene più come vera questa metafisica dell’essere, delle due l’una: o è compromessa l’unità della persona o è compromessa la possibilità di una dimostrazione razionale dell’immortalità dello spirito (come accade in Gaetano).
In conclusione, il secondo presupposto potrebbe essere enunciato in questi termini: la persona umana è una persona corporea, oppure, il corpo umano è un corpo personale.
Da ciò consegue che metafisicamente parlando — e dunque vedendo le cose nella loro più profonda verità — il corpo umano è collocato in un grado dell’essere infinitamente superiore di ogni altro corpo: come quel pezzo di marmo in cui si è espressa l’altissima ispirazione michelangiolesca è ormai incomparabilmente superiore a qualsiasi altro pezzo di marmo. L’alfabeto e le parole in cui è scritta la Divina Commedia sono identici all’alfabeto e le parole con cui il bambino scrive i suoi primi pensierini: ma ciò non impedisce che i due siano imparagonabili. La biochimica oggi ci dice che l’alfabeto (per altro molto semplice, essendo solo di quattro lettere) della vita è sempre lo stesso; ma quando questo alfabeto scrive un corpo umano, ha composto un corpo con un valore, una nobiltà ontologica assolutamente unica.
Da ciò consegue ancora che ciò che è dovuto eticamente alla persona è dovuto al corpo, in quanto è un corpo-persona.
2, 3. Se lo spirito entra nell’essere solo ed esclusivamente per un atto creativo di Dio, il corpo è generato. Anzi, più precisamente: ogni persona umana è il termine di un atto creativo di Dio (in ragione della sua spiritualità) e di un atto generativo umano (in ragione della sua corporeità) (17). Questo dato di ragione (e di fede) sta alla base del terzo presupposto filosofico dell’Istruzione.
Ha fatto molto discutere il giudizio di intrinseca illiceità dato anche sul “semplice caso” della fecondazione in vitro. Esso, tuttavia, è coerente con tutta la visione razionale (e di fede) dell’uomo. Per cogliere questa coerenza, occorre tenere presente il terzo presupposto, che ora cercherò di esporre.
Come ogni relazione, anche quella di paternità-maternità ha un suo fondamento. Fino al 1978, l’uomo fondava esclusivamente questa relazione sull’atto generativo, quell’atto di unione etero-sessuale che dava precisamente inizio al processo generativo. Ora l’uomo può fondare questa relazione sul fondamento di un atto essenzialmente diverso, un atto di carattere tecnico (18).
Ora, la natura metafisica della relazione è determinata dal suo fondamento, come possiamo verificare in qualsiasi relazione. La relazione fra uomo e Dio è essenzialmente diversa dalla relazione fra il giustificato e Dio, perché l’atto creativo è nella sua essenza diverso dall’atto della giustificazione del peccatore, per fare solo un esempio. Il problema in primo luogo metafisico è, dunque, il seguente: di che natura è la relazione fra gli sposi che hanno dato i gameti ed il concepito, quando essa è posta e fondata da un atto essenzialmente tecnico? Già Aristotele aveva profondamente riflettuto sulla essenziale diversità fra il fare tecnico e l’agire e nei nostri anni è stato soprattutto Heidegger a meditare sul logos della tecnicità. Data la natura della tecnica, la relazione da essa posta ed istituita implica una reciprocità di disuguaglianza (19). La persona cioè entra nell’universo dell’essere in un modo che, dal punto di vista dell’intervento umano, non è adeguato, all’altezza della sua dignità e nobiltà ontologica. Solo un atto (non un fare) personale che istituisca una reciprocità nell’amore fra gli sposi può porre le condizioni del concepimento. Solo in questo modo la persona entra nell’essere nel modo giusto (20).
3. Una voce nel deserto?
L’Em.mo Card. Prefetto della Congregazione della Fede terminava la sua riflessione, invitando gli scienziati alla ricerca di vie alternative a quelle moralmente illecite indicate nel documento ed i filosofi e teologi all’approfondimento dell’antropologia ed etica presente nei documento. Quale sarà l’esito di questo invito?
Dai contatti avuti con scienziati, la prima indicazione era ed è già seguita da prestigiosi centri di ricerca. Ma non è il punto che mi interessa in questa sede.
Che sarà, invece, dell’altra proposta? Non è ovviamente per una curiosità divinatoria che mi faccio la domanda, ma per dare un contributo, piccolo, allo sviluppo della riflessione etica nella Chiesa.
Il linguaggio — possiamo partire da questa constatazione — etico è entrato in una vera e propria atmosfera di equivocità. Due partono dal presupposto della dignità della persona, su cui dicono di consentire, e giungono a conclusioni contraddittorie nella soluzione dello stesso problema. E ciò non perché l’uno o l’altro sia caduto in un sofisma nel suo argomentare! Il fatto è che il termine “persona” non ha più lo stesso significato. Questione, dunque, di vocabolario? Purtroppo la cosa è assai più grave. Poiché siamo nel campo dell’etica, esiste un personalismo che di fatto è un anti-personalismo: un amore dell’uomo che, in realtà, è anti-amore dell’uomo, non fa cioè il bene dell’uomo. In una situazione simile — che è tragica per l’uomo — non c’è che una condizione che consenta di superarla: il riferirsi dei due ipotetici disputanti ad un referente che trascenda ambedue e ne misuri l’intelligenza. Nel caso, la realtà della persona umana. Prescindiamo, per il momento, dal criterio veritativo proprio dell’assenso di fede. Ma l’ammissione di questo referente implica a sua volta che l’essere persona umana (la realtà umana) non sia posto dalla conoscenza che l’uomo ne ha: che, cioè, l’essere uomini non sia ciò che l’uomo pensa di essere. L’identità per cui l’uomo è la coscienza che egli ha di sé, rende teoreticamente e praticamente impossibile qualsiasi via di uscita da quella situazione in cui l’uomo è continuamente esposto al rischio di essere odiato mentre gli si dice di amarlo, di essere asservito mentre gli si dice di liberarlo, di essere degradato mentre gli si dice di elevarlo. Perché è impossibile? Identificando la realtà della persona colla coscienza che egli ha di se stessa (21), il criterio veritativo non può essere che quello della coerenza formale logica, dello sviluppo logico. Quando si traduca nel campo dell’agire, esso diviene quello della efficacità (22). La verità consistente nello sviluppo creativo del pensiero, finisce coll’essere identificata colla pura e semplice libertà auto-ponentesi dello spirito. È l’uomo che fa se stesso. Che ne è del rapporto della persona coll’altra? In fondo, niente è per principio contrario alla dignità di questa se non ciò che questa liberamente decide sia tale. La norma fondamentale è quindi: il rapporto fra le persone deve rispettare ciò che ciascuno ha coscienza (ha deciso) di essere. La persona che non ha questa coscienza non entra nella “regola del gioco”, semplicemente perché persona non è, come l’embrione. La comunione interpersonale è costruita esclusivamente dall’auto-coscienza personale, poiché essa non ha altra realtà all’infuori di questa. Non c’è il rischio di confondere bene e male per la persona, poiché è la persona, alla fine, che giudica ciò che è bene-male per sé.
Un personalismo che, con incredibile leggerezza teoretica, ha voluto essere anti-posizione di una metafisica dell’essere (cosmocentrica e non antropocentrica, si disse) o comunque che ha creduto di costruirsi non su quella base, ha mostrato ora la sua intima natura: di essere in realtà un anti-personalismo.
La bio-tecnologia ha avuto un suo aspetto positivo: veritas et per contrarium. Nel senso che, con una spaventosa coerenza in terna, essa non si è fermata davanti a nulla, né intende farlo, coinvolgendo nel suo vortice gli ordinamenti giuridici, le istituzioni coniugali e familiari (come mostra chiaramente il caso di Baby M.). Questa sequela di fatti ci costringe ad un ritorno al fondamento delle nostre antropologie: al fondamento ultimo del nostro pensare l’uomo.
La “caverna” dell’immanentismo entro la quale l’uomo ha deciso di richiudersi lo espone fatalmente allo scambio dei fantasmi colla realtà, in una allucinazione teoretica. Quando ne uscirà? La bio-tecnologia, così come oggi si pratica nell’ambito del concepimento umano, potrebbe svegliarlo da questa allucinazione? Ove cresce il rischio della perdizione, cresce — come ha scritto Hölderlin — la possibilità della salvezza. Ad una condizione: che l’uomo torni alla sua identità di creatura.
NOTE
(1) Si veda nella trad. Reale, presso l’Ed. La Scuola, 1970 (198610), pag. 146 ss.
(2) Esempio insigne di questa “ignorantia elenchi” è l’art. di M. Piattelli
Palmarini in Il Corriere della Sera di venerdì 20 Marzo 1987, pag. 3.
(3) Cfr. Qq. Dd. de Malo, q. 1, a. 4 e 5.
(4) Si accenna qui ad un problema centrale nell’attuale dibattito etico. Rimando solo ad alcune presentazioni sintetiche, R. Spaemann, Etica teleologica o etica deontologica, doc. CRIS, no 49-50, Roma 1983; J. Seifert, Absolute moral obligations towards finite goods as foundation of intrinsically right and wrong actions, in Anthropos 1 (9985), pag. 57 ss.
(5) Si veda, per es. Lezioni sulle prove dell’esistenza di Dio, ed. Laterza, Bari 1984, pag. 26-27.
(6) L’esposizione più chiara di questa tesi si ha in F. Sullivan, Magisterium. Teaching authority in the Catholic Church, Paulist Press, Mahwah , N. J. 1983, pag. 119-173.
(7) Una delle esposizioni più chiare, rigorose e semplici si veda in T. Alvira-L. Clavell-T. Melendo, Metafisica, ed. Le Monnier, Firenze 1987, pag, 102-110.
(8) Si faccia molta attenzione. L’atto libero è considerato come “via per...” non per definire l’essere-personale: via alla definizione non definizione. L’intelletto umano non ha altre strade per conoscere una realtà che le attività di questa, ma le operazioni non sono la realtà. In termini tecnici: l’atto libero è la ratio cognoscendi della persona, ma la persona è la ratio essendi dell’atto libero. Pertanto, può esserci persona senza attività libera, ma non viceversa.
(9) Per cogliere questa riflessione, si pensi al puro atto del volere, senza altre considerazioni, per esempio il momento esecutivo della decisione volitiva, in cui intervengono altre cause.
(10) Per essere precisi, il termine di persona non connota la stessa realtà che il termine sostanza. Quello indica una sostanza e i suoi accidenti (= soggetto sussistente), questo indica solo ciò che è in sé senza i suoi accidenti.
(11) Lo sviluppo spettacolare della biochimica di questi ultimi anni ha confermato quanto già al riguardo lo sguardo metafisico dei pensatori essenziali aveva percepito su questo punto.
(12) Per evitare gravi equivoci, è necessario precisare su questo alcuni termini e concetti. Nel nostro contesto “contingente” è sinonimo di “corruttibile” e pertanto è qualità che deve esclusivamente dirsi degli individui materiali, che “possono essere e non essere”; “necessario” è ciò che non è corruttibile, del quale non si può dire che “può essere e non essere“, ma si deve dire che “necessariamente è”. La distinzione fra questi enti e Dio non è dovuta al fatto che l’essere dei primi è contingente-corruttibile, mentre l’Essere divino è necessario-incorruttibile. La distinzione vera consiste nel fatto che i primi partecipano l’essere (non sono l’essere - sono composti di essenza e atto d’essere), Dio è — al contrario — l’essere stesso ed in Lui non vi è nessuna composizione reale. Di conseguenza, i soggetti spirituali, le persone, possono entrare nell’universo dell’essere solo per un atto creativo di Dio, i soggetti materiali per generazione. Posto l’atto creativo che li pone nell’essere, i soggetti spirituali vi sono necessariamente e nulla ormai potrà più far sì che non siano, se non una decisione di Dio stesso (da escludersi per sé). Posti nell’essere dall’atto generativo, i soggetti materiali, non vi sono necessariamente, ma sempre contingentemente: possono, cioè, esserci e non esserci, in dipendenza dai loro costitutivi. La contingenza è il loro modo di essere, a causa della loro essenza stessa: l’essere — nella sua intensità — è misurato dall’essenza.
Che questo sia il pensiero di san Tommaso, oltre tutto, mi pare non ci debbano essere dubbi: si veda Contra Gentiles lib. 2, 30 e 55; Summa Theologiae 1, 50, 5. Su questa dottrina si veda Cornelio Fabro, L’uomo e il rischio di Dio, ed. Studium, Roma 1967, pag. 241 e 271.
Questa indipendenza nell’essere è ciò che rende possibile un atto come atto libero: solo la persona è libera, poiché l’agire è sempre misurato dall’essere proprio di colui che agisce. E l’atto libero è la suprema manifestazione della persona. Dire, invece, che ne è il costitutivo, è come dire che l’effetto causa la causa: un puro non senso. Questa percezione della necessità (ex suppositione) del soggetto spirituale, ci fa vedere la dignità di questo.
(13) Non sarà inutile richiamare un punto, anche se ovvio. Ciò che l’Istruzione insegna è la dignità incomparabile di ogni persona e la soluzione dei casi che sono stati proposti alla Congregazione. Come si sa dalla più elementare metodologia teologica, il Magistero non impegna la sua autorità sulle ragioni per cui insegna ciò che insegna. La nostra esposizione si rifà ad una precisa metafisica. Tuttavia, ci sembra del tutto necessario lo sforzo, da parte del filosofo e del teologo, di fondare metafisicamente ciò che oggi comunemente è chiamato “personalismo”. Senza questa fondazione si rischia di fare una costruzione che può crollare al primo vento e che resta sempre ambigua.
(14) Si rifletta lungamente su questo punto, poiché dalla risposta a questo punto deriva la sensatezza teoretica delle soluzioni date ai casi affrontati nella seconda parte dell’Istruzione. Se la persona non è il corpo — o, il che è lo stesso, se il corpo umano non è un corpo-persona(le) — non è vero che attingendo il corpo, eo ipso (sempre e comunque) attingo la persona, ho a che fare colla persona.
(15) È necessario non farsi ingannare dall’immaginazione: l’unità del composto umano non può essere immaginata, ma solo pensata. L’immaginazione, infatti, ci porterebbe a pensare secondo questa successione cronologica: prima esiste il corpo da una parte e l’anima dall’altra; poi i due si uniscono e si ha la persona. In realtà non si ha un corpo umano, cioè un corpo-persona che non sia per l’atto d’essere proprio dello spirito umano (il cadavere non è un corpo umano); e così non si ha uno spirito umano che non sia almeno ordinato a comunicare il suo essere ad un corpo. In altri termini: materia e forma non sono realtà che esistono, ma realtà mediante le quali sussiste l’individuo.
(16) Si dovrebbero leggere alcuni mirabili passaggi del De unitate intellectus di san Tommaso nel cap. 3 (ed. Spiazzi n. 234; ora anche in trad. italiana a cura di A. Tognolo in Tommaso d’Aquino, l’uomo e l’universo, ed. Rusconi, Milano 1982, pag. 263 ss).
(17) Non si deve dire che il corpo è generato, ma la persona: ciò che è, infatti, termine dell’atto generativo non è il corpo, che non sussiste, ma la persona che è corpo e spirito. Maria non è la Madre del corpo del Verbo Incarnato, ma del Verbo Incarnato: cioè di Dio. La relazione di paternità-maternità ha come termine la persona, come fondamento l’atto generativo.
(18) Tralascio l’esposizione di questa diversità. Se ne può vedere un’ottima illustrazione in A. Rodriguez Luno-R. Lopez Mondejar, La fecondazione in vitro, ed. Città Nuova Roma 1986, pag.55-67.
(19) Ho lungamente esposto questo punto nel mio studio Il dono della vita: introduzione antropologica, in un’opera di commento alla Istruzione (Autori vari) di imminente pubblicazione presso Vita e Pensiero.
(20) Mi sembra che questi siano i tre presupposti fondamentali antropologici del documento. Non sono gli unici. Ve ne sono altri più regionali, per es. quelli riguardanti il rapporto legge morale / legge civile affrontato nella quarta parte.
(21) Si veda l’ultima esemplificazione in Medical Tribune del 20/2/1987 (pag. 22) con l’affermazione attribuita al prof. Böckle “Das Gewissen-das oberste Instanz”.
(22) Su questa riduzione del pensare (metafisico) alla logica si veda M. - D. Philippe, Signification de la métaphysique, ed. Tequi, Paris 1975, pag. 50-54.
|